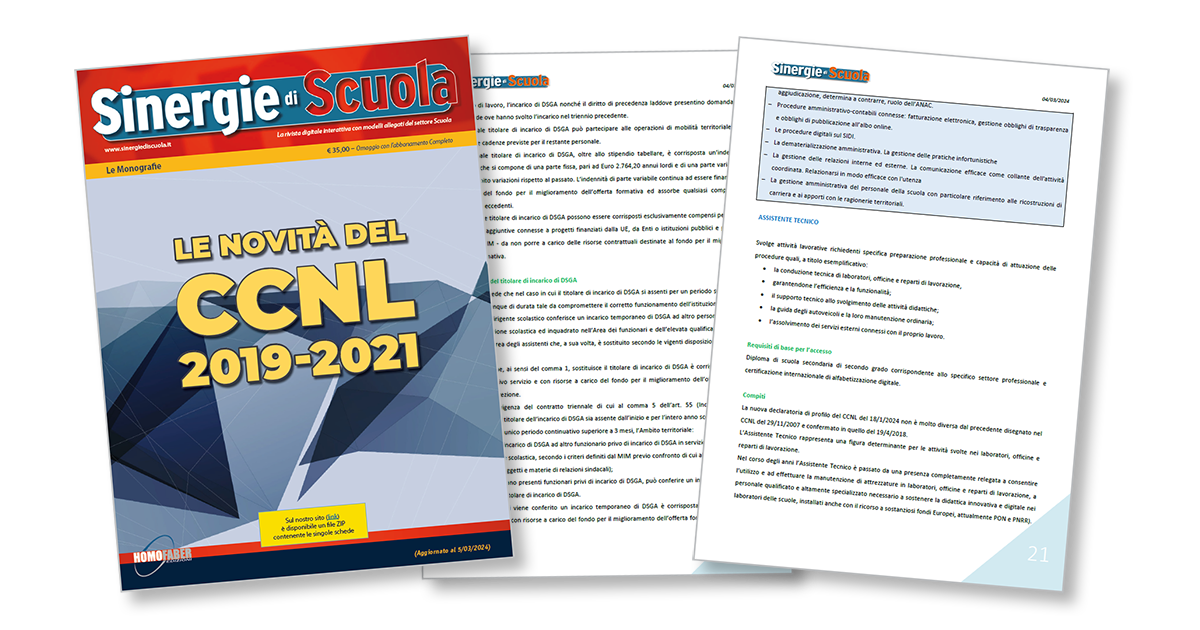La circolare del Ministero n. 1784 del 21/03/2025, avente per oggetto “Chiarimento circa l’uso del simbolo grafico dell’asterisco (*) o dello schwa (ə) nelle comunicazioni ufficiali delle istituzioni scolastiche”, ha avuto un effetto paragonabile, sia pure con una certa immaginazione, a quello indotto dal generale Massimo Decimo Meridio nella foresta della Marcomannia con la famosa frase «Al mio segnale, scatenate l’inferno».
Sembra che all’origine quelli da scatenare fossero stati i cani, soggetti più congruenti con i tempi, ma la successiva modifica aggiunge sicuramente pathos alle circostanze.
La circolare, che in effetti è firmata da un Capo Dipartimento e non dal Ministro, si sofferma sulla necessità di assicurare correttezza e chiarezza nelle comunicazioni ufficiali, citando più volte l’Accademia della Crusca per mettere al bando l’uso di simboli grafici estranei al lessico canonico, quali l’asterisco (*) e lo schwa (ə), che rappresentano «un suono indistinto non presente nella lingua italiana, anche se esistente in alcuni dialetti».
Forse – fatti salvi errori, abbagli e fraintendimenti – in alcuni casi empiricamente individuabili del napoletano, secondo un esempio offerto dalla settima arte, quali piatt* (?), forchett* (?), bicchier* (?), coltell* (?), uom* (?) ...
Comunque sia, il MIM evidenzia che «l’Accademia della Crusca ha avuto modo di precisare più volte che l’impiego nella comunicazione scritta e istituzionale di segni grafici, come gli asterischi, al posto delle desinenze o di altri segni estranei alla tradizione ortografica italiana, come lo schwa, non è grammaticalmente corretto secondo le attuali regole della lingua italiana. Pertanto, è stato raccomandato di attenersi alle strutture grammaticali codificate per garantire chiarezza, leggibilità e accessibilità di testi e documenti».
La circolare fa proprie le raccomandazioni riportate in un parere del 24 settembre 2021, in cui l’Accademia precisa che «L’asterisco non è [...] utilizzabile, a nostro parere, in testi di legge, avvisi o comunicazioni pubbliche, dove potrebbe causare sconcerto e incomprensione in molte fasce di utenti, né, tanto meno, in testi che prevedono la lettura ad alta voce», stante in quest’ultimo caso l’impossibilità della resa fonetica.
Come riportato in circolare, nel successivo parere del 9 marzo 2023 l’Accademia afferma: «Va dunque escluso tassativamente l’asterisco al posto delle desinenze dotate di valore morfologico (“Car* amic*, tutt* quell* che riceveranno questo messaggio...”). Lo stesso vale per lo scevà o schwa [...]».
In conclusione, siccome nel parere del 10 maggio 2024 l’Accademia conferma «[...] che la lingua giuridica e burocratica non sia sede adatta per sperimentazioni innovative che portano alla disomogeneità e compromettono la lineare comprensione dei testi», la circolare ribadisce che «al fine di assicurare correttezza e chiarezza nelle comunicazioni ufficiali, si raccomanda di attenersi alle regole della lingua italiana che consentono l’utilizzo di soluzioni linguistiche comunque conformi alla tradizione ortografica italiana».
Subito dopo, anche la Società Dante Alighieri, l’ente che tutela e diffonde la lingua e la cultura italiana nel mondo, ha voluto estromettere asterischi e schwa perché «in netto contrasto con le regole della lingua italiana», e il Ministro stesso ha così precisato il significato della circolare:
Come ha chiarito l’Accademia della Crusca, il genere neutro non esiste nella grammatica italiana, asterischi e schwa non appartengono alla lingua italiana, sarebbe un atto di violenza imporli e quindi penso che sia doveroso per un ministro dell’Istruzione e del Merito far rispettare le regole della lingua italiana.
È certamente ineccepibile il fatto che la lingua italiana si esprima in un sistema binario (maschio/femmina), mentre lingue classiche (morte?) come il latino e il greco ammettevano l’uso del neutro, un terzo genere, né maschile né femminile, che oggi sopravvive nelle lingue slave e germaniche (però, questi tedeschi, che complicati!). Allo stesso modo, è evidente che, come dice il Ministro, «la lingua di oggi non sia quella di Dante, è evidente. Magari tra cent’anni si dirà bambin*, ragazz* e student* ma oggi credo che nessuno di noi in società sente qualcuno dire “quest* bambin*” o “quel* ragazz*”, è qualcosa di estraneo al linguaggio comune».
La medesima convinzione è stata chiaramente illustrata nel corso dell’assemblea annuale dei soci della Dante Alighieri, riunitisi a Roma il 28 marzo scorso: il presidente Riccardi ha ricordato che nel 2021 il Vicepresidente della Dante, Luca Serianni, si era già espresso in tal senso: «i segni grafici (schwa e asterischi) non hanno un corrispettivo nel parlato. E qualunque lingua è in primo luogo una lingua parlata. Pertanto, ha concluso Riccardi, non vediamo motivo di dover cambiare posizione in merito a un problema così delicato per il presente e per il futuro della lingua italiana, che insegniamo in tutto il mondo. La questione è stata già risolta, per noi, da un linguista così illustre come è stato Luca Serianni e invitiamo pertanto i nostri Comitati a seguire questa chiara presa di posizione».
Se così stanno le cose, ed è indubbio che così stiano, si fa un po’ fatica a capire perché, invece, segni grafici come ad esempio la “chiocciola” o “at” (@), la congiunzione “and” (&) e il “cancelletto” meglio noto come “hashtag” (#) siano diventati di uso comune nella lingua italiana, che ha dato loro un nome e anche una resa fonetica, e a nessuno sia mai venuto in mente di considerarli un atto di violenza perpetrato ai danni del nostro bell’idioma.
Corre l’obbligo di dire che non sorge invece alcun timore per una eventuale futura circolare sull’uso dell’identità “alias”, prevista anche dall’art. 21 del CCNL 2019-2021 per il personale della scuola in transizione di genere, poiché il termine “alias” è un avverbio latino, e siccome il latino è stato recentemente reintrodotto nella scuola secondaria di I grado, non c’è pericolo che il suo utilizzo generi conflitti con la correttezza della lingua, anzi, rientra logicamente in una materia di studio fin dal primo ciclo di istruzione.
Rimane tuttavia qualche perplessità circa l’abuso incontrastato, anzi, quasi compiaciuto degli anglismi da qualsiasi parte ci si voglia girare, compreso l’ambito scolastico, dove la vision e la mission del PTOF sono ormai un classico, il Piano Scuola 4.0 richiama ad una più forte attenzione alle performance, ai risultati e al raggiungimento di target e milestone previsti nella road map, oltre che agli approcci pedagogici fondati sul learning by doing e sul problem solving, l’ultimo CCNL raccomanda moduli organizzativi di formazione che rafforzino l’empowerment del personale, il MIM crea una piattaforma di crowdfunding specifica per le scuole statali, gli Istituti Tecnologici Superiori diventano ITS Academy e l’innovativo percorso liceale messo in opera per promuovere il patrimonio italiano si chiama Made in Italy.
È logico che dal Ministero dell’Istruzione e del Merito si raccomandi di «attenersi alle strutture grammaticali codificate» per farsi capire e non creare sconcerto e incomprensione negli sprovveduti destinatari, ma viene da chiedersi se, in presenza di abbondanti guide, manuali e pubblicazioni contenenti regole e consigli per scrivere bene i testi amministrativi (ad esempio, “Scrivere chiaro” dell’Unione Europea) sia stato imprescindibile fornire ai Dirigenti scolastici quel tipo di chiarimento sull’uso corretto della lingua, della grammatica e delle modalità di redazione comprensibile dei testi.
Sarà forse perché, secondo una recente indagine OCSE, in Italia il 35% degli adulti rientra nella categoria degli analfabeti funzionali, coloro cioè che sanno leggere e scrivere ma hanno difficoltà a capire e utilizzare le informazioni contenute in un testo scritto, o forse semplicemente perché la lingua italiana ha bisogno di regole, essendo un organismo vivente che cambia e si evolve, come il tempo.
E tutte le volte che si parla del tempo, come diceva Oscar Wilde, «provo la chiara sensazione che si voglia parlar d’altro».