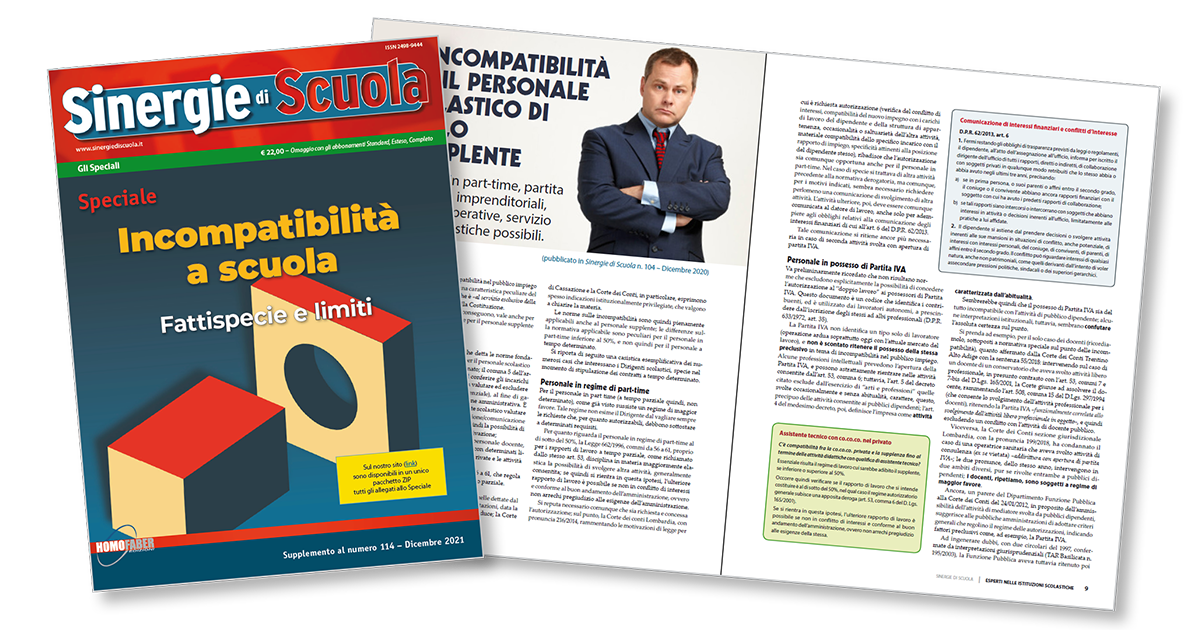Quali sono le nuove abilità necessarie ai giovani per affrontare attivamente il mondo moderno?
La domanda è sempre più attuale, specie in quei paesi, come gli Stati Uniti, che negli ultimi venti anni hanno visto calare lentamente, ma in maniera inesorabile, l’efficacia del proprio sistema scolastico, e – come conseguenza di medio periodo – la propria capacità economica nel contesto globale. È infatti notizia di questi giorni che la Cina è ormai prossima a scalzare gli USA dal primo posto tra le potenze economiche, posizione che gli americani detenevano ininterrottamente dal 1875, quando superarono l’economia inglese.
Consapevoli che in una società iperconnessa il vecchio nozionismo non può più essere sufficiente, laddove invece assumono un ruolo determinante capacità trasversali, prima fra tutte l’attitudine al problem-solving (si legga in proposito anche a pag. 14), già da tempo si indagano in maniera sempre più scientifica i meccanismi dell’apprendimento, e si studiano nuove tecniche di insegnamento.
Tra queste, si guarda con interesse in America all’apprendimento partecipativo, come l’aveva definito il professore universitario Henry Jenkins in un suo celebre articolo del 2006, “Affrontare le sfide della cultura partecipativa”, col quale analizzava le radici della creatività e gli effetti che su di essa hanno una società connessa e la possibilità di condividere i progetti on-line. A quell’articolo Jenkins ha dato seguito creando un gruppo di studio, che da allora indaga sulle competenze che occorre sviluppare negli studenti per consentire loro di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Frutto del lavoro è la strategia PLAY (Participatory Learning and You), che «descrive un modo alternativo di sperimentare le materie di studio, più simile a come i bambini si approcciano istintivamente ai giochi quando ne sperimentano i limiti, liberi di provare e sbagliare». Cosa invero difficile da adottare in ambito scolastico, dove l’errore – seppur riconosciuto utile nel percorso formativo – è deprecato e sanzionato dal voto negativo.
Ma ciò che definisce in concreto il metodo PLAY è l’attenzione alla creatività, all’apprendimento di gruppo (mutuando il concetto dall’ambito lavorativo, in cui la collaborazione arricchisce i progetti), a motivare la partecipazione attiva, a pensare all’istruzione come un’ecosistema, dove i collegamenti tra scuola, casa, comunità e resto del mondo hanno pari importanza.
In questo contesto le nuove tecnologie hanno un ruolo importante, ma non come strumenti da imparare ad usare ai fini di un futuro lavorativo, bensì come mezzi per sperimentare nuove tecniche, esprimere il potenziale creativo. Proprio le tecnologie informatiche degli ultimi anni hanno visto nascere nuove abilità – come la capacità di visualizzare, organizzare e comprendere le informazioni visuali, o il multi-tasking, o ancora sapere cogliere le possibilità offerte dalle infrastrutture interconnesse – che i giovani mostrano di sapere usare e manipolare con una dimestichezza inarrivabile per la maggior parte degli adulti. In questo l’apprendimento può persino diventare bidirezionale, con gli studenti che insegnano al docente nuove tecniche o l’uso di strumenti diversi, come avvenuto in molte scuole dove il metodo PLAY è in corso di sperimentazione.
La critica più forte a questa metodologia è il grado di libertà concessa agli studenti, che se gestito male dal docente può condurre a situazioni di “caos (in)controllato”. Eppure si riscontra negli studenti coinvolti un entusiasmo per la scuola e lo studio mai provato prima. Una frase ricorrente tra gli studenti di tutto il mondo è: «Perché devo imparare queste cose, tanto non mi serviranno mai!». Ma questa frase non si sente nelle classi dove si effettua la sperimentazione...
Abbiamo tutti negli occhi la scena di “Apollo 13”, quando agli ingegneri della Nasa viene chiesto di creare in brevissimo tempo un filtro per l’anidiride carbonica per l’equipaggio in pericolo di vita, col solo materiale a disposizione nella navicella. Quell’attitudine squisitamente americana, ma anche italiana (come dimostrano i test PISA citati a pag. 14), non va dispersa, ma anzi valorizzata in questi tempi complicati. Forse la metodologia PLAY non sarà la risposta, ma indica una direzione, che è sempre più importante non trascurare.