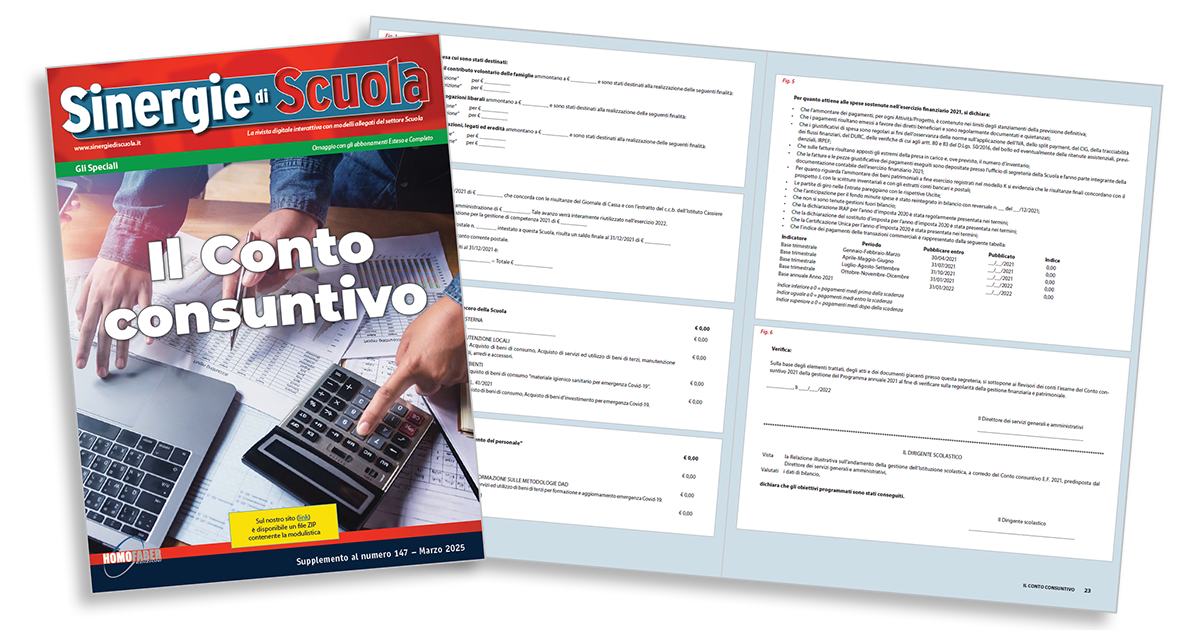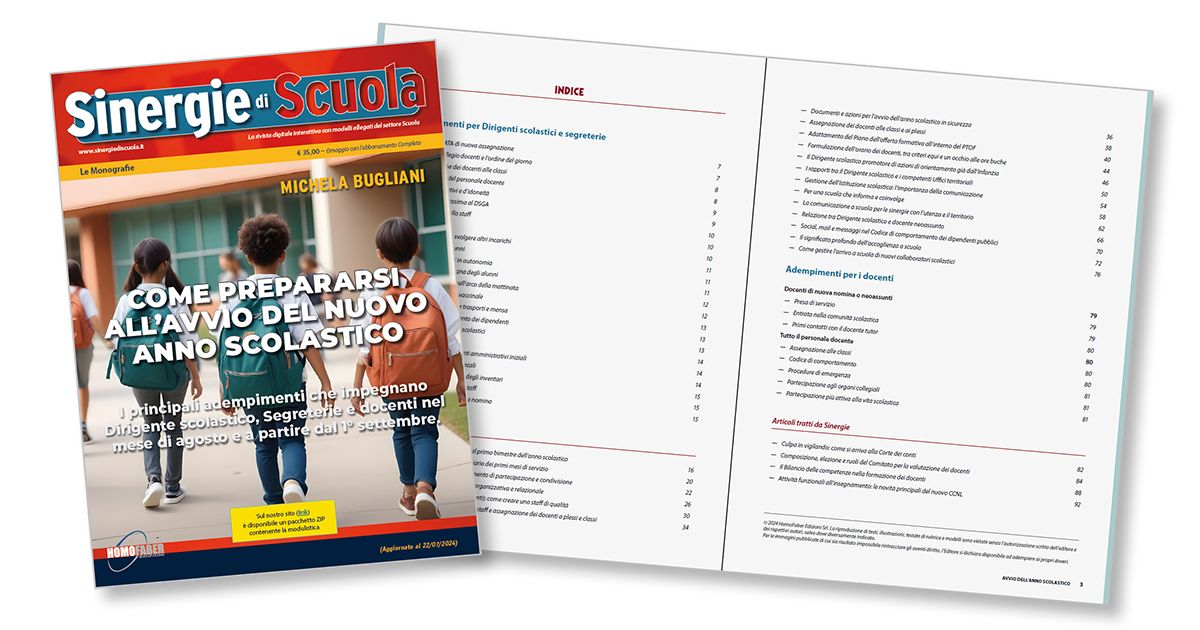La fattispecie del danno erariale interessa e riguarda ogni dipendente pubblico.
La figura consiste, in parole semplici, in un danno alle casse dello Stato, che può essere:
- diretto, se causato in via immediata (caso tipico il peculato, ravvisabile quando ci si appropria di denaro o beni in propria disponibilità per ragioni di ufficio);
- indiretto, qualora lo Stato sia costretto a risarcire un terzo e, successivamente, si rivolga al pubblico dipendente causa principale del danno (caso tipico, il danno da risarcimento allo studente per mancata vigilanza dell’insegnante).
Quindi, ogni dipendente pubblico è responsabile amministrativamente quando causa un danno allo Stato; per l’esatta configurazione del danno erariale sono sempre e comunque necessari alcuni elementi, ovvero:
- elemento soggettivo, consistente nell’aver agito con dolo o colpa grave;
- elemento oggettivo, ovvero concreta esistenza del danno quale diretta conseguenza di una condotta antigiuridica imputabile al dipendente;
- rapporto di servizio con la PA;
- nesso causale tra condotta e danno.
La questione dell’individuazione concreta del danno erariale può, spesso, non essere semplice: non sempre è connesso a fattispecie penalmente rilevanti; inoltre, negli ultimi anni la figura è stata oggetto di declinazione variegata e non univoca da parte dell’organo deputato a riconoscerlo, ovvero la Corte dei Conti, che ha sviluppato una serie davvero numerosa di possibili configurazioni di danno.
Per fare degli esempi assolutamente non esaustivi dell’ampia casistica, ricorrono:
Danno all’immagine
Si verifica quando, a seguito di sentenza, il dipendente sia riconosciuto colpevole di pregiudizio al prestigio e alla reputazione della PA, aggravato dal fatto che sussista anche il clamor fori, ovvero il rilievo mediatico della notizia potenzialmente comportante atteggiamento di sfiducia nelle istituzioni di parte della collettività.
Danno da demansionamento
È ipotesi di danno derivante dalla “sottrazione”, da parte del datore di lavoro, di alcune delle mansioni originariamente assegnate al lavoratore (c.d. demansionamento quantitativo), o dalla diminuzione della rilevanza e della qualità professionale di tali mansioni, ovvero l’attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle svolte inizialmente (per queste ultime due ipotesi si parla di demansionamento qualitativo). Sul punto è intervenuta la Corte dei Conti, sez. Lazio, con la pronuncia 390/2016.
Danno erariale da disservizio
Si configura a causa di una perdita, o una mancata entrata contabile, per una condotta del lavoratore difforme dai propri obblighi di servizio, ed è passibile di numerose declinazioni pratiche (ad esempio, il dipendente che causa dispendiosi interventi tecnici per ripristinare l’efficienza della strumentazione informatica danneggiata da programmi scaricati per fini privati).
L’elencazione potrebbe ricomprendere altre figure (danno da soccombenza giudiziaria, danno da lesione della concorrenza ecc.) a conferma non solo che la fattispecie del danno erariale, non tipizzata dalla legge, assume vesti sempre più variegate, ma che chi opera giornalmente per le Amministrazioni dello Stato dovrebbe informarsi con cura sui rischi potenziali quotidiani.
Un caso di condanna per danno indiretto in ambito scolastico
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Umbria, con la sentenza 87/2022, è intervenuta in proposito di danno indiretto imputabile ad un Dirigente scolastico. Il fatto riguardava una lavoratrice di una scuola, la quale era rimasta incastrata nel cancello carrabile della stessa riportando gravi lesioni e conseguente invalidità e correlati danni patrimoniali, che il MIUR, in sede civile, era stato condannato a risarcire.
Dalle indagini svolte risultava che il Dirigente scolastico, con colpa grave, aveva omesso di richiedere all’Ente locale competente le dovute riparazioni segnalando lo stato di pericolo di due cancelli di ingresso al plesso scolastico; la segnalazione era intervenuta tardivamente, dopo ben 6 mesi dal sinistro.
La Corte, pur riconoscendo che gli obblighi di manutenzione e riparazione fossero in capo al Comune, sottolinea l’obbligo di segnalazione in capo al Dirigente, indicando inoltre che l’art. 46, comma 2 del D.M. 44/2001, comunque consentiva che all’Istituzione scolastica di anticipare i fondi necessari all’esecuzione di lavori urgenti e indifferibili, dandone immediata comunicazione all’Ente locale competente, ai fini del rimborso.
La magistratura evidenzia, viceversa, come nel caso di specie si fosse verificata una antidoverosa omissione di tempestiva segnalazione dei guasti dei due cancelli, il carrabile e il pedonale, e che tale inerzia si fosse addirittura protratta anche per molti mesi dopo il sinistro, come confermato anche dal Comune, che dichiarava l’assenza di interventi straordinari e l’esecuzione regolare di quelli di mantenimento.
Varie testimonianze, inoltre, riportavano come il cancello funzionasse male già da tempo, sia quello pedonale, bloccato per lunghi periodi, sia quello elettrico, non riparato nemmeno dopo l’infortunio.
La Corte sottolinea «come è, del pari, allarmante che il Dirigente scolastico, in presenza di utenti minori di età non abbia provveduto con solerzia a far riparare entrambi i cancelli (pedonale e carrabile) , onde evitare infortuni quali quello occorso a [...] E, ancor di più, che non si sia attivato tempestivamente, quanto meno per chiedere un controllo approfondito della funzionalità del cancello, atto a scongiurare il reiterarsi di episodi analoghi».
Prosegue la Corte: «Orbene, il Dirigente scolastico è titolare di una specifica posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, essendo equiparabile in ragione del ruolo e ad un datore di lavoro responsabile della sicurezza, tanto che, in caso di negligente omissione, ne può rispondere anche penalmente (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 37766/2019). Nella fattispecie in esame, poiché si è verificato a causa della carenza di manutenzione dei cancelli non imputabile, neppure parzialmente, al Comune di Terni, ente, in quanto direttamente derivata dalla grave omissione del convenuto, deve ritenersi che [...] siano stati cagionati per effetto della violazione degli obblighi, di vigilanza e di segnalazione, cui il [...] era tenuto nella qualità di responsabile della sicurezza del personale e degli utenti e che egli debba in questa sede essere di conseguenza ritenuto responsabile anche del corrispondente danno pubblico indiretto scolastica».
Interessante è la motivazione del riconoscimento della colpa grave del Dirigente scolastico, per cui la Corte riconosce che «la gravità della colpa è ulteriormente confermata dalla circostanza che, persino dopo il grave infortunio occorso alla dipendente, il malfunzionamento non è stato tempestivamente segnalato e prontamente fatto riparare dal convenuto, che ha in tal modo perseverato in un atteggiamento di negligenza e imprudenza».
Altra ipotesi di responsabilità erariale dirigenziale
Il Dirigente scolastico risponde per responsabilità civile, penale, disciplinare e, appunto, erariale. Ipotesi spesso ricorrente è quella relativa a responsabilità del Dirigente per mancata vigilanza o segnalazione in caso di condotta illecita del dipendente, che non esime tuttavia il personale di vertice dalla possibilità di rispondere di responsabilità erariale, qualora ne ricorrano gli estremi.
È un caso verificatosi varie volte, come affrontato, ad esempio, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza. 277/2019, a proposito di un giudizio di responsabilità nei confronti di una dipendente e del Dirigente; il giudizio prendeva le mosse da un esposto relativo al mancato rispetto dell’orario di servizio da parte di una dipendente di un Istituto scolastico che, con autorizzazione della dirigenza, attestava il servizio (pari alle canoniche 36 ore settimanali) non con il badge, ma tramite firma di entrata e uscita su un apposito registro. Proprio dal registro, la Dirigente verificava una diminuzione di fatto dell’orario, e impartiva disposizioni di servizio per far rispettare l’orario alla dipendente, oltre ad informare il servizio ispettivo dell’USR competente, che – a sua volta – irrogava sanzione disciplinare.
La Corte giunge alla condanna per responsabilità erariale della dipendente (riconoscendo «La condotta illecita, consapevole e volontaria, è connotata dal dolo civile contrattuale, quale inadempimento volontario dell’obbligazione contrattuale, caratterizzato dalla previsione e coscienza dell’evento dannoso»), ma, ciò che è di maggiore interesse giuridico, sanziona anche la Dirigente. Risulta dalle motivazioni della sentenza che la Dirigente, cui spettano «obblighi organizzativi di amministrazione e controllo sull’attività degli operatori scolastici», ammise di non aver svolto nessun controllo sul registro delle presenze, fatto confermato anche da altri testimoni facenti parte del personale dipendente. Ebbene, il mancato controllo indusse la Corte a riconoscere lo stato soggettivo rilevante per la responsabilità erariale, riconoscendo la colpa grave della parte dirigenziale scaturente proprio dall’omesso controllo, sintomo per la Corte di superficialità e negligenza, che avrebbero indotto, o comunque aggravato, il fatto causativo del danno, ovvero l’autoriduzione dell’orario di lavoro della dipendente.
La sentenza ha riconosciuto carico della Dirigente responsabilità a titolo di colpa grave in via sussidiaria, calcolata nel 20% della somma ascritta alla dipendente, a favore, in entrambi i casi, dell’allora MIUR.