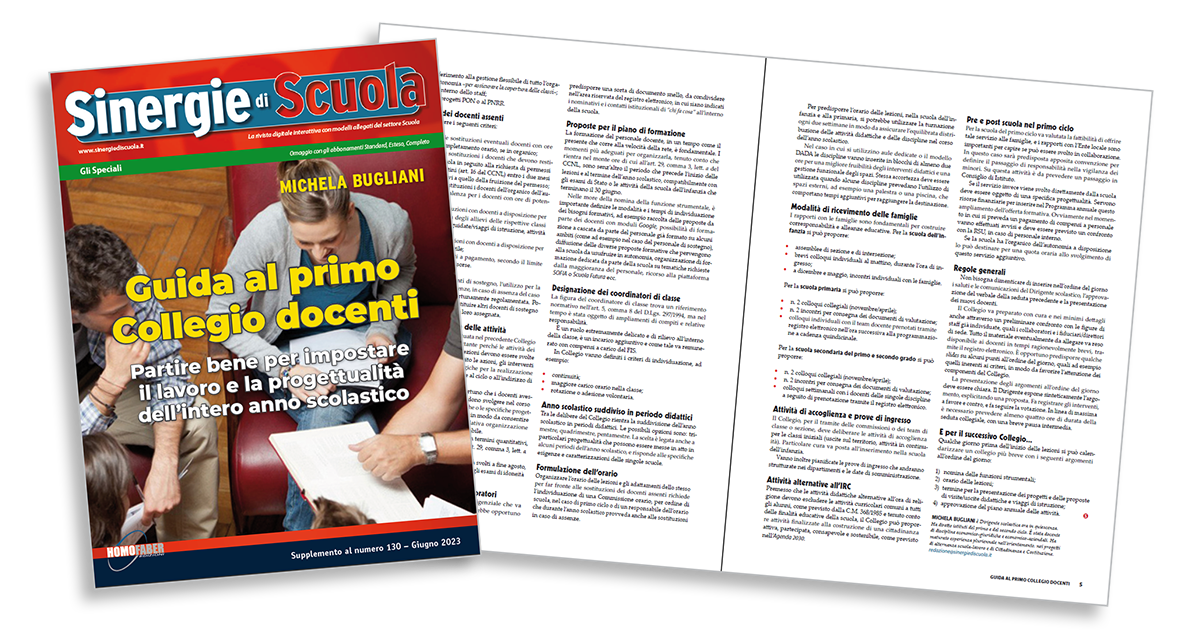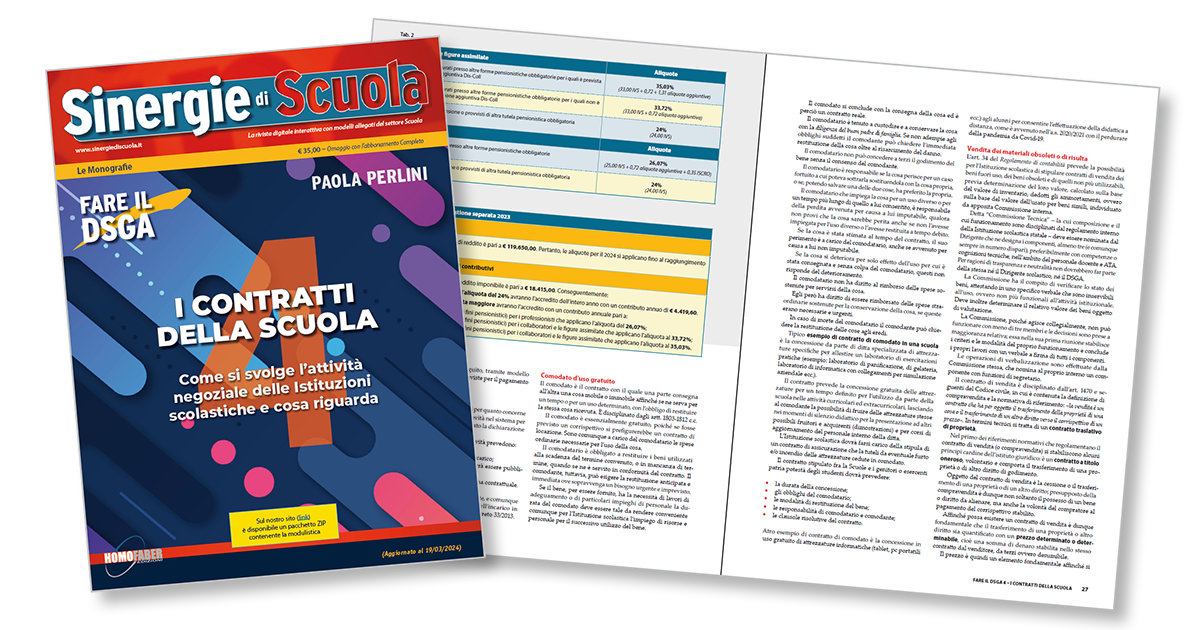La Corte di Cassazione, Sez. I penale, con la sentenza n. 17603/2016, congiuntamente alla precedente pronuncia della Sez. V penale, 3 aprile – 2 agosto 2013, n. 33753, ha annullato la decisione del Tribunale di Cagliari, che aveva assolto un rappresentante sindacale di un liceo dal reato di diffamazione, nei confronti del Dirigente scolastico, in relazione ad uno scritto, redatto e affisso nella bacheca delle comunicazioni sindacali, dal seguente contenuto:
“È squallido il comportamento del preside che fa il processo sommario al docente in un presunto consiglio di classe allargato. Questo preside non è all’altezza del proprio compito!”
Secondo il Tribunale, infatti, sarebbero ricorsi tutti gli elementi per giustificare l’aspra critica rivolta dal sindacalista al preside, fondata sulla circostanza che il fatto contestato era realmente avvenuto (un professore di matematica era stato oggetto di aspre critiche relative alla sua capacità professionale, da parte di genitori di una classe nel corso di una riunione scuola/famiglia alla presenza del Dirigente scolastico, che non avrebbe preso le difese dell’insegnante) e la sua conoscenza era rilevante per tutta la comunità scolastica; inoltre, le espressioni usate, per quanto pungenti, sarebbero rientrate nei limiti della critica sindacale. Questa ultima implica infatti giudizi di valore che risentono di una valutazione soggettiva, nel cui ambito le frasi colorite e i moduli espressivi volutamente enfatizzati vanno filtrati alla luce della natura e delle finalità del linguaggio sindacale, il cui contenuto altamente polemico e aggressivo deriva dall’esigenza di tutelare la professionalità e i diritti inviolabili dei lavoratori.
Requisiti essenziali del diritto di critica
Premesso che la critica consiste in un’attività eminentemente valutativa, in un dissenso, o in consenso, per lo più ragionato rispetto alle opinioni o alle condotte altrui, e, sotto il profilo intrinseco, si configura come un’analisi di eventi, condotte, fenomeni, allo scopo di apprezzarne l’intimo significato e le conseguenze che siano a questi causalmente riconducibili (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Cedam, Padova, 1998, p. 177), la giurisprudenza e la dottrina considerano legittimo l’esercizio del diritto di critica quando ricorrono determinati requisiti, in difetto dei quali si possono commettere specifici reati, come quello di diffamazione, ingiuria ecc.
I suddetti requisiti, peraltro citati dallo stesso giudice cagliaritano, sono:
- La veridicità dei fatti sui quali si fonda la critica. Il diritto di critica, pur concretizzandosi nella manifestazione di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, presuppone comunque un contenuto di veridicità, limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass., Sez. V, n. 13264/ 2005; Cass., Sez. V, 14/02/2002, n. 20474; Cass., Sez. V, 14/04/2000, n. 7499).
- La rilevanza sociale del fatto, cioè l’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto di critica.
- La continenza, cioè la correttezza del linguaggio usato.
Pur essendo evidente che il diritto di critica è esercitabile grazie alla previsione dell’art. 21 della Costituzione, il quale tutela la libertà di manifestazione del pensiero, esso non può oltrepassare i tre limiti ben precisati prima, sfociando in ingiurie, contumelie e offese gratuite o trascendendo in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato (Cass., Sez. V, n. 748/1999; Cass., Sez. V, n. 5071/1986).
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha respinto la tesi assolutoria del Tribunale, innanzitutto rilevando da un lato che era infondata l’accusa, diretta al Dirigente scolastico, di non aver respinto con decisione le censure sollevate dai genitori verso l’insegnante, anzi di averle indirettamente condivise, poiché i testimoni hanno dichiarato in giudizio che il preside ha svolto correttamente il ruolo di mediatore/moderatore nel corso della discussione, senza parteggiare per le famiglie degli alunni; dall’altro, che era stato travalicato il limite della continenza formale della critica.
La Cassazione ha pertanto correttamente statuito che le espressioni del sindacalista non potevano in alcun modo rientrare nel legittimo diritto di critica, poiché erano oltremodo offensive (un preside non può essere etichettato come “squallido”, aggettivo che usualmente significa triste, misero, inadeguato, ma che, in questo caso, assume la diversa accezione di “moralmente abietto e ripugnante”), al di fuori del rispetto delle regole giuridiche e della civile convivenza, trasmodando in un attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale e intellettuale del contraddittore, anziché essere espressione di dissenso motivato, manifestato in termini misurati e necessari.
La Suprema Corte ha inoltre fondato il proprio convincimento sulla circostanza che lo scritto oltraggioso affisso in bacheca era lacunoso, non consentendo, infatti, a coloro che non avevano partecipato alla riunione, di conoscere come si erano svolti i fatti e, di conseguenza, di comprendere i termini delle critiche rivolte al Dirigente scolastico.
Il lettore, perciò, poteva unicamente percepire un attacco immotivato alla libertà personale e professionale del capo di istituto, senza essere in grado di formarsi una opinione. La critica, quando si esprime nella stigmatizzazione di comportamenti o fatti, deve avere per connotato essenziale l’obiettivo di contribuire all’approfondimento della conoscenza e alla formazione di un giudizio autonomo da parte dei destinatari del messaggio, altrimenti è impossibile ricostruire il contesto e decifrare i termini adoperati e, conseguentemente, ravvisare la giustificazione dell’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero critico.
È stata dalla Corte respinta pure la teoria difensiva del sindacalista volta a distinguere il comportamento del Dirigente scolastico dalla persona del dirigente stesso: l’aspra critica, a detta della difesa, sarebbe stata rivolta non al preside in quanto tale, bensì al suo comportamento ritenuto umiliante e discriminatorio.
Questa teoria è naufragata innanzi alla connotazione personale delle espressioni usate dal sindacalista, che sono state indirizzate direttamente «al preside che fa il processo sommario»: non dunque al comportamento, quindi, ma al suo autore.
Quando invece non c’è diffamazione
Il lettore, però, non deve farsi trarre in inganno: l’idoneità a diffamare delle espressioni usate da un sindacalista, come da qualunque altro soggetto, devono essere valutate di volta in volta, in base alla particolarità del caso concreto, pur avendo quale regola di giudizio i tre parametri illustrati in precedenza.
Può accadere, perciò, che espressioni che secondo il sentire comune sembrino ingiuriose, siano lecite per il giudice che le esamina.
Si è affermato, infatti, che «non esula dai limiti del diritto di critica sindacale, e non è quindi suscettibile di dar luogo a penale responsabilità per il reato di diffamazione, l’affermazione, contenuta in un comunicato affisso alla bacheca esistente nel luogo di lavoro secondo cui la mancata promozione di un dipendente al ruolo dirigenziale sarebbe stata “una vera mascalzonata”, imputabile a soggetti nominativamente indicati, per non avere essi pubblicizzato, in violazione degli accordi sindacali, la disponibilità del posto in questione e per non avere tenuto, uno di essi, un comportamento definito “intimidatorio” nei confronti del suddetto dipendente, al quale era stata prospettata la convenienza di non coltivare ulteriori vane speranze di avanzamento di carriera, ma di accettare piuttosto una proposta di prepensionamento onde evitare un progressivo depauperamento del previsto premio di buona uscita» (Cass., Sez. V, 14/04/2000).
Parimenti, è stata esclusa la configurabilità del reato di diffamazione a carico di un sindaco, il quale, a fronte del mancato sgombero delle strade dall’accumulo di neve, abbia affermato, in una missiva diretta al Presidente della provincia, che il soggetto cui, dall’amministrazione provinciale, era stato affidato il relativo servizio, lo svolgeva con «menefreghismo e scarsa professionalità» (v. Cass. pen., Sez. V, 06/02/2008).
Allo stesso modo si è ritenuto che «le espressioni “compagni di merenda” e “di brigata” non appaiono idonee al superamento del limite della continenza, poiché il diritto di critica presenta una sua necessaria elasticità e non è necessariamente escluso dall’uso di un epiteto infamante, dovendo la valutazione del giudice di merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi particolarmente aspri sia o meno funzionale all’eventuale assoluta gravità oggettiva della situazione rappresentata» (Cass. pen., Sez. I, 29/10/2009, n. 41551).
Onde evitare che l’eccessiva suscettibilità del destinatario delle espressioni critiche possa determinare la condanna dell’autore della presunta diffamazione, esiste una massima, seguita in giurisprudenza, secondo la quale «quando la critica consiste in varie espressioni di dissenso, queste devono essere intese nel senso che più presumibilmente l’autore a esse conferisce e non possono essere interpretate forzatamente nel modo offensivo che appare al querelante» (cfr. G.i.p. Trib. Milano 07/04/1997).
Un’ultima significativa sentenza merita di essere ricordata, perché illustra correttamente le condizioni in presenza delle quali è pienamente legittimo il diritto di critica sindacale, addivenendo ad una pronuncia di assoluzione.
La Cassazione, Sez. V, 20/09/2013, n. 38962, ha difatti premesso, con riferimento alla critica sindacale, che:
“[...] sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica sindacale (art. 51 c.p.) qualora il rappresentante di un’organizzazione sindacale indirizzi una missiva a vari enti istituzionali nonché alla stessa parte lesa, che censuri le scelte di quest’ultima – effettuate in qualità di Capo dell’Ufficio di Procura, in ordine alla gestione del personale amministrativo – ipotizzando a suo carico la realizzazione di comportamenti penalmente rilevanti [...]”
E ha dunque stabilito:
“[...] l’assenza di una connotazione personale delle espressioni – tutte rivolte al risultato dell’attività e non al suo autore – e la loro funzionalizzazione allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi dei lavoratori interessati giustificano la conclusione raggiunta dal giudice di secondo grado [di assoluzione dell’imputato, n.d.a.].
A ciò deve aggiungersi che le modalità di estrinsecazione del diritto di critica non hanno superato i limiti della continenza espressiva perché il carattere “sconcertante” o “grottesco” o “borbonico” della situazione, definita come “vergogna aziendale”, senza tradursi in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale dell’odierno ricorrente, denuncia, come si diceva, il risultato dei denunciati favoritismi”.
Così come le pronunce sopra esposte hanno ritenuto legittimo l’esercizio del diritto di critica sindacale, è pacifico che biasimare, con modi urbani, l’operato di un professore, non espone al rischio di condanna per diffamazione.
Lo testimonia la sentenza della Cassazione, Sez. V penale, n. 11154/2006, che ha ritenuto non integrante il reato di diffamazione, l’esposto presentato da alcuni genitori al Provveditorato agli Studi di Sassari, con il quale essi evidenziavano che un insegnante della classe frequentata dai loro figli, nel corso dell’anno scolastico, non aveva fornito agli studenti il necessario supporto didattico; che aveva contribuito a creare negli studenti problemi di natura psicologica a causa degli atteggiamenti arroganti tenuti, corredati talvolta da espressioni non proprio civili e alle disparità di trattamento riservate agli alunni, specie di sesso maschile; che nell’esercizio della sua attività aveva omesso le interrogazioni durante l’anno scolastico e le aveva talvolta sostituite con prove scritte, del cui esito gli alunni erano stati informati solo in occasionali colloqui.
L’assoluzione è frutto di due considerazioni principali:
- la critica aveva tratto argomento dall’esperienza personale, per come raccontata dai figli, vissuta nelle assemblee di classe, ed era stata espressa in termini corretti nell’esposto indirizzato, su consiglio dello stesso Preside, al Provveditore;
- l’esposto non aveva una vera e propria capacità diffamatoria in quanto, promosso all’interno dell’istituzione scolastica, fu poi inviato dai soggetti legittimati a farlo, solo ed esclusivamente all’autorità gerarchicamente superiore deputata al dovuto controllo (Provveditorato, ora Ufficio scolastico territoriale), senza essere comunicato a più persone (estranee ai fatti), facendo venire meno, per ciò solo, il presupposto per configurare il reato di diffamazione.