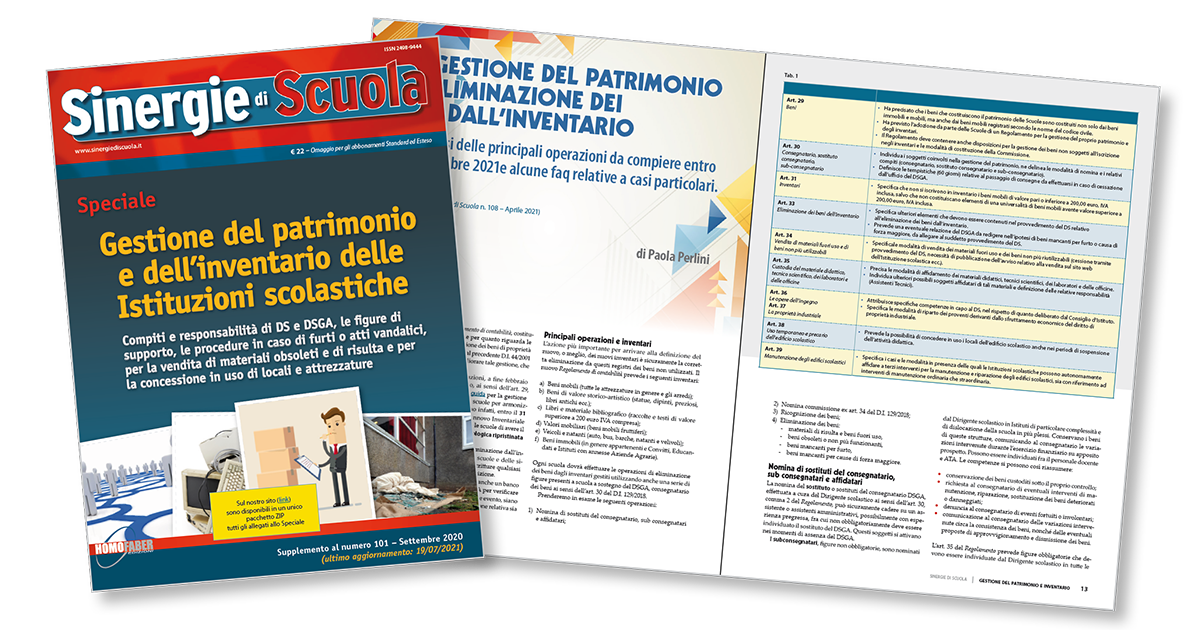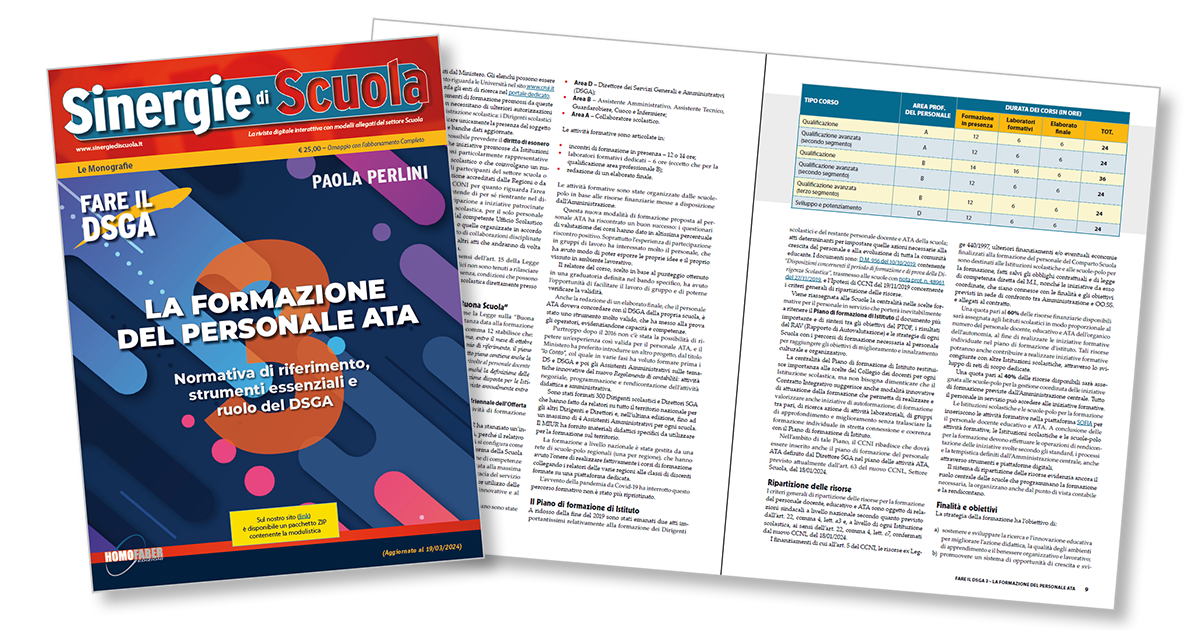In questo articolo ci occupiamo di una sentenza di condanna per atti vandalici (e altri reati), perpetrati dagli studenti a danno delle strutture scolastiche.
Lo facciamo, questa volta, da un’angolazione particolare.
Il caso
Il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza del 28/04/2010, dichiarava colpevoli di concorso nel reato di danneggiamento dei locali della scuola due alunni, che avevano provocato una devastazione così grave da turbare la regolare attività delle lezioni, rendendo l’edificio scolastico temporaneamente inagibile (avevano forzato la porta d’ingresso, aperto i rubinetti dei bagni e otturato i tombini, allagando tre piani dell’edificio scolastico e provocando, in tal modo, l’indebolimento delle strutture in muratura. Non contenti, avevano imbrattato i muri e le finestre con vernice spray, svuotato gli estintori e disperso la polvere ovunque). Avevano, inoltre, minacciato un testimone oculare, loro compagno, tanto da meritarsi una condanna, oltre che per danneggiamento, anche per interruzione di pubblico servizio e minaccia.
Confermata la condanna in appello, sebbene a pena ridotta, gli imputati avevano proposto ricorso per Cassazione.
La particolarità della vicenda posta all’esame degli Ermellini (Cass., Sez. II penale, 14/03/2013 n. 11888) consiste nella circostanza che i docenti avevano tenuto alcune riunioni con gli alunni della scuola per parlare dell’accaduto. E, in quelle occasioni, si erano raccolti indizi sulle responsabilità delle devastazioni.
Il primo quesito che deve trovare risposta da parte della Cassazione è se il materiale raccolto nel corso di tali riunioni sia utilizzabile nel processo penale come prova.
Presentando ricorso in Cassazione, i difensori dei due ragazzi, infatti, avevano contestato proprio «l’inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle confidenza acquisite dal personale docente».
La Suprema Corte ha precisato che durante gli incontri tra il personale docente e gli alunni, peraltro autorizzati dalla dirigente scolastica, non si era inteso ricercare i colpevoli, poiché a tale scopo erano già impegnati, nelle indagini sui reati commessi, gli organi di Polizia, bensì stimolare una riflessione sull’accaduto, sollecitata anche dagli studenti che liberamente vi avevano partecipato e spontaneamente consegnato le loro dichiarazioni sugli episodi di vandalismo, appositamente allegate alle relazioni consegnate dai professori al capo d’istituto.
Il punto è proprio questo: qualora il comportamento dei professori fosse stato qualificabile come “attività ispettiva e di vigilanza”, volta a identificare i colpevoli, essa avrebbe travalicato le loro competenze, essendo tale attività demandata, all’interno del settore scolastico, al servizio ispettivo ministeriale e alla dirigenza scolastica. Il materiale raccolto, pertanto, sarebbe stato inutilizzabile come prova.
Gli incontri con gli studenti hanno avuto, ricordano i giudici, valore di «richiamo al senso civico degli studenti, alcuni dei quali avevano riferito spontaneamente quanto a loro conoscenza». In questo contesto, precisa la Corte, si giustifica la trasmissione alla dirigente scolastica, da parte dei docenti, di relazioni, protocollate come riservate, con allegati gli scritti consegnati dagli studenti.
Il giudice di legittimità ha fugato, inoltre, qualsiasi dubbio circa un probabile condizionamento da parte dei professori verso gli alunni, sostenendo che spetta al giudice del merito (cioè il giudice di primo e secondo grado), valutare la portata degli scritti degli studenti, anche tenendo conto delle circostanze in cui sono state rese e che, in seguito a tale valutazione, non è emersa alcuna costrizione, nei confronti degli allievi, “a confessare” quanto conosciuto.
Ciò premesso, le dichiarazioni sottoscritte e consegnate da alcuni studenti ai professori nel corso delle predette riunioni, sono state acquisite all’interno del procedimento penale, come documenti rappresentativi di un fatto storicamente avvenuto, rimesse all’apprezzamento del giudice circa la loro valenza probatoria (anche le videoriprese, avvenute in aula, sono considerate prove documentali, quando siano formate fuori dal procedimento penale, cioè non ad opera della polizia giudiziaria).
Il giudice di merito ha, di conseguenza, ritenuto attendibile il contenuto di tali documenti, considerando reticenti alcuni allievi che, innanzi al magistrato, non avevano confermato le dichiarazioni scritte, sostenendo di non ricordare nulla e, in taluni casi, disconoscendo la loro sottoscrizione o addirittura negando di aver parlato del fatto con i professori.
Il reato di minaccia
È necessario svolgere alcune considerazioni proprio in merito a questo ultimo reato, poiché – come spesso accade – i vandali, se sospettano di poter essere individuati grazie al racconto di eventuali testimoni, tendono a “convincere” questi ultimi a tacere o a non raccontare la verità sugli accadimenti.
La minaccia è un reato di pericolo (art. 612 c.p.), ciò significa che non presuppone, ai fini della punibilità del colpevole, la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo l’idoneità della condotta del reo ad intimidire la vittima. Non occorre, inoltre, che il male minacciato sia ben specificato, purché sia ingiusto, dipenda dalla volontà del delinquente e possa essere dedotto dalla situazione contingente, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità del colpevole, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali.
Nel caso di specie, le ritorsioni minacciate, benché indeterminate, nel contesto sociale di riferimento dei protagonisti della vicenda, lasciavano immaginare quanto meno una forma di ostracismo nei confronti della testimone degli atti vandalici, nel caso avesse rivelato quanto era a sua conoscenza, e quindi una situazione di esclusione sociale sicuramente pregiudizievole per l’alunna, ingiusta e dipendente dalla volontà degli autori dei fatti incriminati.
Emblematica è la pronuncia di Cass. n. 36700/2008, che ha ritenuto sussistere il reato di minaccia aggravata in capo al docente che aveva minacciato una ingiusta bocciatura ad una propria allieva. I giudici hanno ritenuto sussistente la minaccia grave, argomentando che per una studentessa la ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze, tale da poter configurare l’aggravante in questione.
Del tutto inconferente è stato ritenuto, inoltre, il rilievo, fatto dal professore, secondo cui il reato non sarebbe configurabile in quanto il male minacciato (ingiusta bocciatura) non dipendeva dalla volontà dell’imputato, ma da un organismo collegiale (consiglio di classe).
Per la sussistenza del reato di cui all’art. 612 c.p. l’idoneità della condotta va valutata, insegna la Suprema Corte, secondo un giudizio ex ante (l’espressione indica che il giudizio va ricondotto al momento della commissione dell’ultimo atto che ha caratterizzato il comportamento dell’insegnante), tenendo conto di tutte le circostanze che in base ad un criterio medio possono essere considerate al momento della condotta.
L’impossibilità di realizzare il male minacciato esclude il reato solo se si tratti di impossibilità assoluta, non quando la minaccia sia comunque idonea ad ingenerare comunque un timore nel soggetto passivo. Nella specie, i giudici del merito hanno riconosciuto che la minaccia di una ingiusta bocciatura, rivolta dal professore, fosse idonea ad ingenerare nella studentessa forti timori, incidendo la sua libertà morale.
Il reato di minaccia è procedibile a querela; se la minaccia è particolarmente grave o è stata posta in essere con armi, o da più persone riunite, o da persone che si siano rese irriconoscibili perché “travisate”, non c’è bisogno di querela: si procede d’ufficio, bastando cioè che il magistrato abbia ricevuto in qualunque modo notizia del fatto.
I docenti, quindi, venuti a conoscenza di un comportamento minaccioso di un alunno nei confronti dei suoi compagni, non sono obbligati, tranne nei casi più gravi previsti dal codice penale, ad informarne immediatamente l’Autorità giudiziaria.
Coloro che hanno l’incarico di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, invero, hanno l’obbligo (artt. 362 e 358 c.p.), solo in presenza di reati procedibili d’ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa), tra i quali non rientra il reato di minacce (non aggravate), di denunciare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia il dovere di riferire a quella, come ad esempio i Carabinieri, la Polizia ecc.), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.).
In generale, poiché al Dirigente scolastico e ad esso soltanto (artt. 25, D.Lgs. 165/2001 e 396, D.Lgs. 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l’esterno (v. Cass. n. 11597/1995), il personale docente e in generale il personale scolastico assolvono l’obbligo in questione riferendo al Dirigente scolastico la notizia di reato di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici ecc.) che abbia eventualmente raccolto la segnalazione o che abbia avuto diretta osservazione e percezione del fatto costituente reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri).
La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo (così Caragliu - Paolucci “Responsabilità penale e minori: il ruolo del Dirigente scolastico”, Usp Novara).