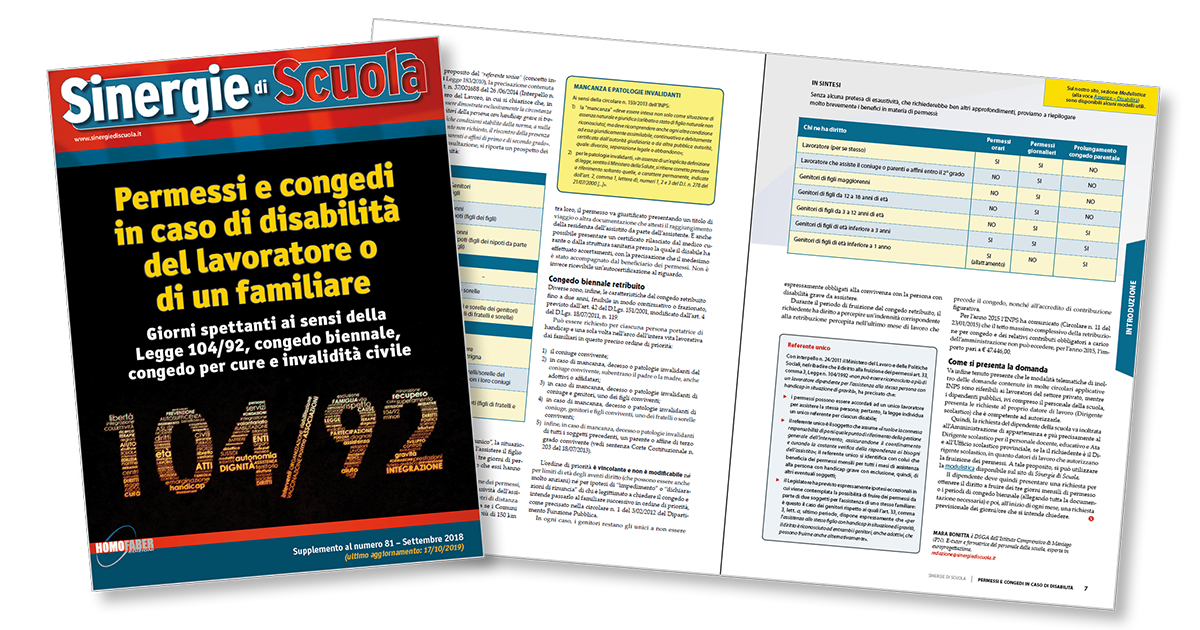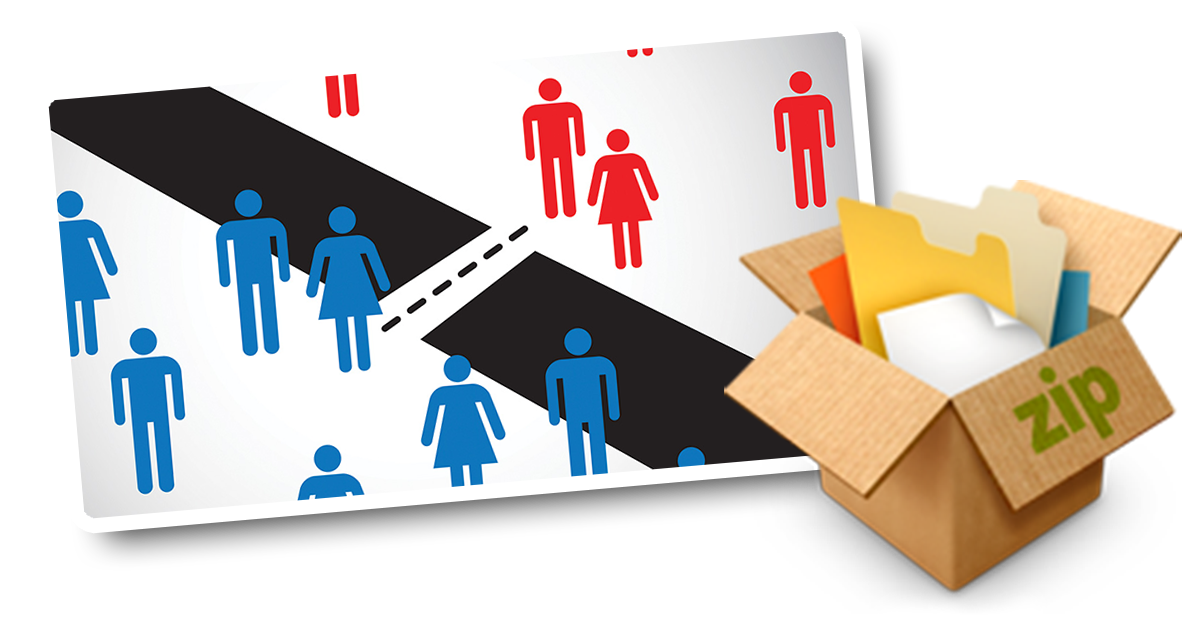Un recente articolo apparso su Il Fatto quotidiano ha riportato alla memoria un triste fatto di cronaca: il suicidio di una studentessa diciassettenne, Maria Rosaria Grillo, occorso nel 1996, quando frequentava l’Istituto magistrale statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia.
Il 13 giugno di quell’anno la ragazza raggiunse la scuola dove avrebbe dovuto sostenere un’interrogazione. Alle 8.40, tuttavia, non era ancora presente in classe: venti minuti più tardi fu trovata appesa con una cintura di cuoio ad un tubo dei riscaldamenti che si trovava a due metri di altezza nei bagni. I tentativi di rianimarla furono tutti inutili, e la ragazza spirò poco dopo in ospedale.
Dell’evento luttuoso è stato ritenuto responsabile il MIUR, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Catanzaro nella sentenza 18/06/2009, confermata nel febbraio 2015 dalla Corte d’appello.
Dall’esame della pronuncia del Giudice calabrese, emergono alcuni aspetti giuridici in merito alle condizioni in presenza delle quali può essere attribuita la responsabilità dell’evento morte al Ministero dell’istruzione, al potere-dovere di sorveglianza dei docenti, alla prevedibilità del comportamento della vittima, e ai danni risarcibili.
Procediamo con ordine…
Preliminarmente occorre illustrare (e smontare) la tesi difensiva del Ministero, il quale nel processo ha sostenuto che la responsabilità doveva essere eventualmente ascritta all’istituto scolastico presso il quale si era verificato l’evento: le scuole sono dotate di personalità giuridica autonoma ai sensi dell’art. 21, Legge n. 59/1997, e del d.P.R. n. 275/1999 e, quindi, risponderebbero in prima persona (senza coinvolgere il Miur stesso) degli eventi dannosi in esse verificatesi.
Ho più volte ribadito nei miei interventi che, nel caso di infortunio occorso ad un alunno per la mancata vigilanza da parte della scuola, per far valere il diritto al risarcimento del danno può essere citato innanzi al giudice solo il MIUR, e non l’istituto scolastico, in quanto l’art. 61, comma 2, della Legge 11/07/1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione – salvo rivalsa verso l’insegnante colpevole di omessa sorveglianza (ma solo nei casi di dolo o colpa grave) – nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da alunni che abbiano subito un infortunio, esclude in radice sia la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando sia, di conseguenza, le scuole presso le quali svolgono le loro mansioni (cfr., tra le tante, Cass., Sez. III, 6/11/2012, n. 19158).
Più solida, invece, appare l’affermazione del Ministero convenuto che mette in luce come il suicidio fosse stato «predeterminato dalla minore, cosicché nessuna responsabilità poteva ascriversi all’amministrazione scolastica, atteso che la stessa può ritenersi sussistente soltanto nei casi di comportamenti dei docenti integranti il dolo o la colpa grave. In particolare, la colpa grave va correlata ad un comportamento tale da configurare un alto tasso di prevedibilità rispetto alla verificazione dell’evento dannoso e, pertanto, non può essere riconosciuta nel caso di specie».
In altri termini, il suicidio deve considerarsi un evento difficilmente prevedibile e, quindi, al docente non può rimproverarsi di non aver vigilato: se un allievo decide di porre fine alla sua esistenza isolandosi nel bagno della scuola è arduo sostenere che l’insegnante avrebbe potuto impedire l’evento.
In astratto il ragionamento del convenuto è condivisibile, ma il Tribunale di Catanzaro lo contesta, spostando l’attenzione sul concreto verificarsi dei fatti:
[la studentessa] era uscita di casa alle ore 8.00 circa per recarsi a scuola [...]. Alle ore 8.40 era entrata nell’istituto scolastico la sua compagna di banco, V., la quale, recatasi in aula, aveva chiesto della M. alle altre compagne di classe, ma queste, prese da altri discorsi, non l’avevano ascoltata e non le avevano risposto. Poco dopo aveva sentito delle grida provenienti dal corridoio, dove si era recata immediatamente, constatando che la sua amica si era impiccata. La minore M. era stata trovata nei locali adibiti a servizi igienici da un’altra alunna dell’istituto scolastico, Z., che si era casualmente recata in bagno per fumare una sigaretta ed aveva quindi subito dato l’allarme [...].
In nessuna di dette testimonianze e in nessuno dei documenti acquisiti in copia dai Carabinieri si dà atto della situazione all’interno della classe che M. frequentava. Non viene, infatti, riferito o documentato se nella classe fosse già presente l’insegnante (al momento dell’accaduto, presumibilmente, dovevano essere già iniziate le normali attività didattiche) e se fosse già stata annotata, quella mattina, la presenza degli alunni sul registro di classe. Non vi è, peraltro, tra le documentazioni acquisite, la copia del registro della classe frequentata dalla minore M.
Le lacune organizzative e di vigilanza del personale scolastico sono evidenti e hanno provocato l’inadempimento del fondamentale obbligo della scuola di protezione dell’integrità psicofisica degli allievi che la frequentano.
Le mancanze dell’istituto
Come più volte affermato dalla giurisprudenza, nei casi di danni auto-inflitti dagli alunni (sui quali consentitemi di richiamare il mio articolo “La vigilanza a scuola e il caso fortuito”, pubblicato nel num. 16 – Febbraio 2012 di Sinergie di Scuola), la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale e, a fronte di ciò, l’alunno deve provare soltanto che il danno si è verificato nello svolgimento del rapporto, ossia in orario scolastico, l’amministrazione scolastica di provare, invece, che il danno è stato determinato da una causa non riconducibile né alla scuola, né all’insegnante.
Nei casi come quello trattato, la domanda che si pone il giudice, per formulare un’eventuale sentenza di condanna, è la seguente: cosa non hanno fatto il preside, il docente e, più in generale, la scuola (e che invece erano tenuti a fare) per evitare che l’alunna si suicidasse? Quali sono i mezzi organizzativi predisposti dalla scuola per evitare simili accadimenti? Il personale è addestrato a riconoscere i sintomi che possono portare un minorenne a togliersi la vita?
La responsabilità dell’insegnante che non ha tenuto un comportamento vigile è una responsabilità per omissione, che intanto può essere ad esso ascritta laddove non abbia adottato le cautele minime richieste dal buon senso e dai propri doveri professionali. Abbandonare la classe senza farsi sostituire da un collega o da un collaboratore scolastico, per tutto il periodo dell’assenza, è sicuramente un comportamento imprudente, ma anche sottovalutare eventuali spie del disagio dello studente il quale arrivasse a compiere il gesto estremo, potrebbe configurare una responsabilità omissiva del docente.
Si pensi, in proposito, ad un tema assegnato agli studenti dal quale emergesse uno stato evidente di emarginazione di uno di essi, conseguente ad una situazione familiare problematica o a fenomeni di bullismo non adeguatamente contrastati dall’istituzione scolastica: il non avere affrontato la situazione coinvolgendo la famiglia ed, eventualmente, i servizi sociali, potrebbero essere preso in considerazione dal giudice per verificare se la dirigenza scolastica e i docenti abbiano fatto quanto in loro potere per evitare l’evento dannoso auto procuratosi dall’allievo.
Intanto, negli USA...
Massimo Foglia, nel suo articolo “Duty to prevent the suicide: i confini dell’obbligo di protezione in capo all’insegnante”, descrive casi simili a quello che stiamo commentando, verificatisi negli Stati Uniti, all’interno dei college e università americane. Essi hanno suscitato un vivace dibattito nella dottrina americana, divisa tra i sostenitori dell’attribuzione di un sostanziale duty to prevent (the suicide) (dovere di prevenire il suicidio) in capo al personale degli istituti, e coloro che, diversamente, avversano tale posizione — giudicandola oltranzista — stante l’oggettiva impossibilità, da parte dei college, di assumere un ruolo di super-controllore nei confronti degli studenti, sino ad evitare loro di procurarsi danni volontariamente autoinflitti. La soluzione adottata dalle Corti americane sta nel mezzo, e ciò costituisce un efficace spunto per orientarsi anche all’interno dell’ordinamento italiano.
Nel caso Schieszler v. Ferrum College, «il giudice ha riconosciuto la sussistenza di una “special relationship” (speciale rapporto) tra lo studente e il college, quale fonte di un dovere di protezione a tutela del primo, poiché i fatti allegati dimostravano una “imminent probability” (imminente probabilità) che lo studente tentasse di recare danno a se stesso; e il convenuto, che era evidentemente a conoscenza di questo rischio, è stato negligente nel non aver adottato adeguate precauzioni affinché allo studente non fosse consentito di mettersi in pericolo. Il concetto di foreseeability (prevedibilità) è risultato decisivo del caso de quo, sicché, secondo la Corte distrettuale, il personale dell’istituto, allarmato dagli accadimenti e dalle informazioni raccolte dalla fidanzata del suicida, non avrebbe dovuto lasciarlo solo nella sua stanza. Solo la presenza di queste particolari circostanze di fatto, però, ha indotto il giudice ha ritenere sussistente una speciale relazione tra il college e lo studente, giacché senza precedenti avvisaglie di pericolo, ovvero nel caso in cui l’istituto non fosse stato a conoscenza — non per sua colpa — della situazione pregiudizievole, in capo al convenuto probabilmente non sarebbe stato riconosciuto un effettivo duty to prevent the suicide (dovere di prevenire il suicidio).
L’altra vicenda si riferisce alla pronuncia Shin v. MIT. In Shin è interessante notare che l’attore ha agito altresì per breach of contract (inadempimento, mancato rispetto del contratto), sostenendo che l’istituto sarebbe rimasto inadempiente rispetto all’obbligazione di fornire la promessa assistenza medica, come articolato nella brochure del suo dipartimento medico. La Corte Suprema del Massachussets ha comunque statuito che «there is no contract between MIT and the Plaintiffs», poiché le dichiarazioni contenute nella brochure suddetta, non sono «definite and certain» ma «too vague and indefinite to form an enforceable contract » (troppo vaghe e indefinite per costituire un valido contratto); così come le affermazioni fatte dalla direttrice del campus secondo le quali ella si sarebbe impegnata ad informare i genitori della studentessa di ogni susseguente sviluppo circa la sua salute, secondo la S.C., non sono configurabili alla stregua di una «specific promise» sulla quale gli attori avrebbero bene potuto fare affidamento.
Pur tuttavia, la domanda è stata accolta nei termini di una responsabilità di tipo extracontrattuale (cioè non legata al mancato rispetto di uno specifico dovere contrattuale, bensì al dovere della scuola di non provocare danni agli alunni, nel senso di non aver impedito che gli stessi si siano auto danneggiati). La S.C. ha infatti stabilito che, stante la consapevolezza da parte degli amministratori del college circa i gravi disturbi mentali della studentessa, nonché dei numerosi tentativi di suicidio posti in essere dalla stessa e più volte segnalati al personale competente, gli attori hanno fornito prova sufficiente del fatto che gli amministratori «could reasonably foresee that Elizabeth would hurt herself without proper supervision» (avrebbero potuto ragionevolmente prevedere che Elizabeth avrebbe procurato un danno a se stessa senza una adeguata vigilanza). Pertanto — ha proseguito la S.C. — deve ritenersi sussistente una «special relationship» tra la studentessa e gli amministratori del MIT, da cui scaturisce un «duty to exercise reasonable care to protect Elizabeth from harm» (dovere di prestare una ragionevole attenzione per proteggere Elizabeth dall’evento lesivo) in capo ai primi.
L’Autore prosegue traendo le dovute conclusioni: «In primo luogo, se è vero che non esiste un generale “duty to rescue” (dovere di salvataggio, ndr.) nei confronti di una persona — seppur in grave pericolo — sulla quale non sussiste alcuna situazione di controllo, è altrettanto vero che fa eccezione il caso in cui tra le parti sussiste una “special relation” (come nel rapporto precettore/allievo), in virtù della quale la parte cui è affidata la custodia è titolare di un “duty to protect”».
«Ciò è stato messo in evidenza anche dalla citata giurisprudenza sia in Schieszler v. Ferrum College, che nel caso Shin v. MIT, dove i giudici hanno difatti riconosciuto [...] la sussistenza di una effettiva special relation che impone ai college ed alle università un dovere di protezione; dovere che si traduce a sua volta nell’obbligo di adottare tutte quelle misure preventive idonee e necessarie ad evitare il verificarsi di un evento suicida. Conclusione cui si è pervenuti pur rimanendo indefinito e variabile il perimetro di tale obbligo di proteggere, benché le condizioni entro cui la relazione speciale possa dirsi esistente, da questa prima analisi, sembrano concentrarsi nel requisito di un certo grado di “foreseeability” dell’evento dannoso; senza il quale pare non sorga alcuna relazione foriera di obblighi protettivi».
Un altro caso in Italia
I doveri di protezione appena descritti sembra che non siano stati osservati dalla scuola nella quale si era tolto la vita circa tre anni fa Andrea, lo studente quindicenne di un liceo di Roma, impiccatosi stringendo una sciarpa attorno al collo, per i continui sfottò dei compagni sul web per la sua presunta omosessualità.
La causa scatenante il gesto funesto è con tutta probabilità da attribuirsi agli atti di persecuzione e bullismo di cui sarebbe stato vittima, contro i quali la scuola non avrebbe approntato alcun rimedio efficace.
Come ricordano i giornali che si sono occupati della vicenda, per il procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani e il pubblico ministero Pantaleo Polifemo, i docenti «avevano il dovere di censurare le offese indirizzate dai compagni di classe ad Andrea. E invece sono rimasti indifferenti ai comportamenti offensivi degli studenti». Anche la preside del liceo è stata indagata poiché nonostante fosse a conoscenza delle vessazioni, non ha ordinato ai professori di porre un freno al dileggiamento di Andrea.
La colpa di costoro sarebbe stata la sottovalutazione dell’impatto delle offese sullo studente, come confermato dai compagni e amici di classe, i quali hanno affermato che Andrea «è stato vittima di persecuzioni dei coetanei avvenute nella completa noncuranza degli insegnanti».
In conclusione
Facendo tesoro delle indicazioni sin qui emerse, si può affermare che la responsabilità dell’insegnante per la morte di uno studente della propria classe si può imputare solo qualora l’insegnante si fosse accorto (o avrebbe dovuto accorgersi usando la normale diligenza) della situazione di emarginazione o sofferenza dell’alunno (soprattutto se essa era già emersa a seguito dei contatti tra la scuola e la famiglia), laddove il minorenne fosse stato lasciato solo per un arco di tempo non compatibile con il suo stato depressivo (es. a “dimorare” nella toilette per un periodo non congruo).
Al di fuori di questi confini, invece, ritengo che non si possa addebitare alla scuola alcuna responsabilità, qualora l’organizzazione fosse tale da escludere negligenze nella sorveglianza, a meno di considerare a rischio tutti coloro che sono particolarmente fragili o introversi e che devono, come Maria Rosaria, affrontare l’ultima interrogazione dell’anno o una prova particolarmente impegnativa.
Un’ultima precisazione. Il Miur è stato condannato a risarcire ai genitori della studentessa il danno (non patrimoniale) conseguente la perdita di una figlia, denominato “danno da perdita del rapporto parentale”. Essendo un danno da lesione di un bene (la vita) che non ha un valore di mercato (la vita di una persona non si può vendere, né affittare), ma che comunque deve essere quantificato, almeno in via approssimativa ed equitativa, il Giudice calabrese ha applicato i criteri di liquidazione di tale posta di danno facendo riferimento ad apposite tabelle (elaborate dal Tribunale di Roma, ma in uso anche presso il Tribunale di Catanzaro) che tengono conto, tra l’altro, della convivenza di ciascun danneggiato con la vittima e la presenza o assenza di altri familiari conviventi, della giovane età del defunto e di ogni altro elemento in concreto rilevante per la quantificazione del pretium doloris, riconoscendo alla famiglia di Maria Rosaria la somma di 221.562 euro.