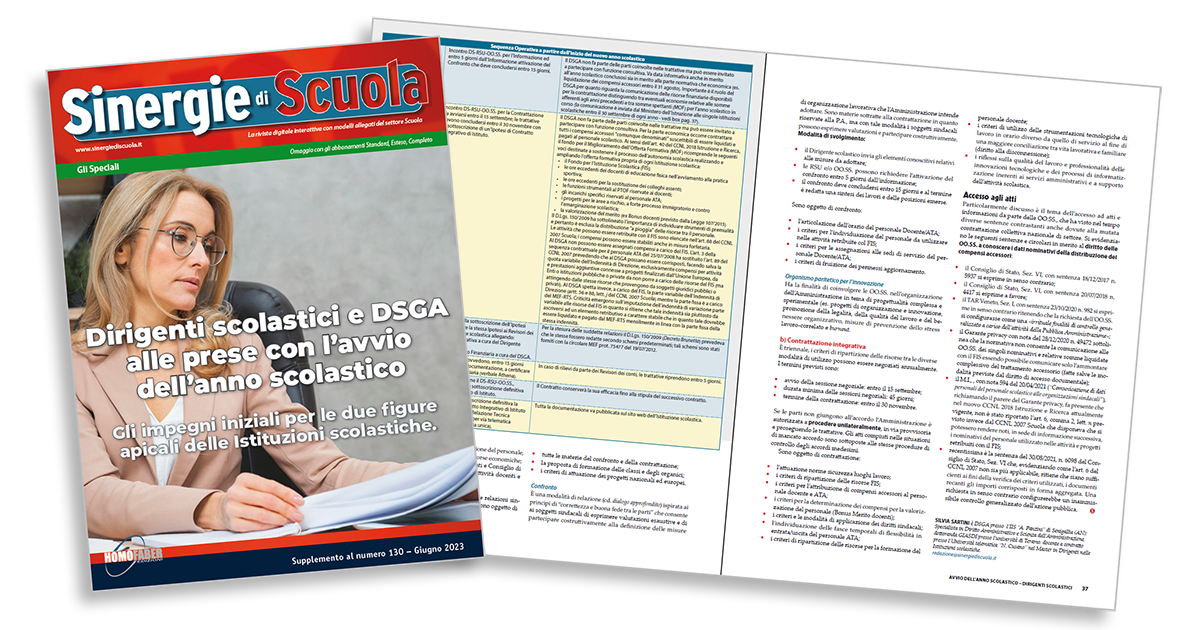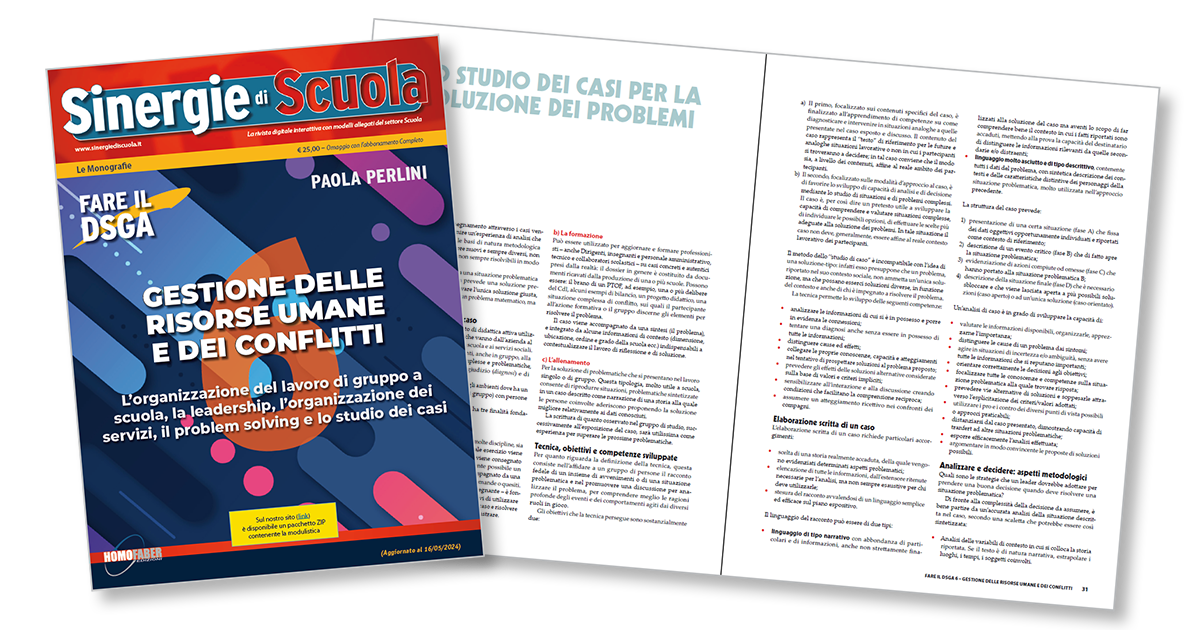La disciplina relativa alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e in particolare, per quel che più direttamente attiene alle nostre riflessioni, le integrazioni ad essa derivanti dal Decreto Brunetta (D.Lgs. 150/2009), si sono innestate su un sistema, quello di cui all’art. 112 del D.P.R. 5/1957, che prevedeva la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale, successivamente modificato dalla possibilità per la contrattazione collettiva di disporre diversamente (art. 74, comma 3 del D.Lgs. 29/1993) e infine “stravolto” dalla disciplina legale “imperativa” di cui al predetto Decreto Brunetta (artt. 68-70) che ha innovato, in parte de qua, il Testo Unico del Pubblico Impiego – TUPI (D.Lgs. 165/2001).
L’intervento del Decreto Brunetta in ambito disciplinare, materia storicamente disciplinata dai contratti collettivi del lavoro privato, è, a modesto parere di chi scrive, esemplificativa del fatto che la “privatizzazione” del rapporto di pubblico impiego non sia poi così integrale, anzi!
Infatti, tanto l’ultimo CCNL 2016-2018 per i Dirigenti scolastici (art. 31) quanto quello del personale docente e ATA per lo stesso periodo (art. 16), non fanno che riproporre in materia quella che è la disciplina legale dell’istituto – e non potrebbe essere diversamente, avendo però cura di specificare quelli che sono i diritti del lavoratore riammesso in servizio.
L’art. 55-ter, comma 1 del TUPI, introdotto dal Decreto Brunetta, e il principio di tendenziale autonomia del procedimento disciplinare da quello penale che esso sancisce, risponde all’esigenza di scongiurare che la Pubblica Amministrazione sia costretta a lasciare impunite le violazioni disciplinari, per un tempo anche lungo o comunque indefinito, visti anche i tempi della giustizia italica, in una logica che non considera la sanzione disciplinare come uno strumento esclusivamente repressivo, ma ne manifesta viceversa la natura di mezzo per gestire con efficienza le risorse umane.
Si consideri peraltro che, nel pubblico impiego, sussiste un vincolo indissolubile, anche successivamente all’adozione del provvedimento sanzionatorio (art. 55-ter, commi 1 e 2, art. 653 c.p.p.), rispetto al giudicato penale, sicché è naturale che a ciò si accompagni una sensibile discrezionalità nel valutare se condurre a termine il procedimento disciplinare, pur a procedimento penale pendente.
In buona sintesi, la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di fatti di maggiore gravità e nella ricorrenza di situazioni più complesse, si denota come una facoltà della Pubblica Amministrazione, esercitata nell’interesse del buon andamento di essa e in attuazione di un canone di prudenza, che di detto principio è espressione, e che è immanente ai parametri di complessità di accertamento o insufficienza degli elementi disponibili, cui fa riferimento l’art. 55-ter, comma 1.
Cosa dice il TUPI
Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
La norma è chiara, il procedimento disciplinare e quello penale sono autonomi e indipendenti tra loro, vediamo quindi quali sono le eccezioni al suddetto principio.
Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD), nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
In primis, quindi, i fatti per cui si procede debbono essere gravi, in quanto “sanzionabili”, ove accertata la responsabilità del dipendente, con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 11 giorni o più, sino al licenziamento senza preavviso. La valutazione sul tipo di sanzione che potrebbe essere applicata è chiaramente resa sulla base di un giudizio prognostico ex ante, effettuata astrattamente con riferimento agli illeciti previsti dalla legge o dal Contratto, e non deve esser fatta ex post, al termine del procedimento disciplinare, con riferimento dunque alla sanzione poi concretamente irrogata.
Ma ciò non è sufficiente per sospendere il procedimento, in quanto ci si deve trovare in casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non si disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione.
Non è quindi necessario attendere il termine del procedimento penale, in quanto il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l’Amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concluderlo, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.
L’esercizio della facoltà discrezionale dell’Amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare è dunque legata a valutazioni oggettive, chiaramente sindacabili dal giudice del lavoro, chiamato eventualmente a giudicare della legittimità dell’operato datoriale.
La sospensione o meno del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale determina due possibili esiti di questo: la ripresa o la riapertura del procedimento medesimo.
In linea generale, si riprende un procedimento che è stato sospeso, mentre si riapre un procedimento diversamente già chiuso.
Analizziamo dapprima quest’ultima ipotesi.
Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’UPD, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.
Quindi, nel caso in cui il procedimento penale si concluda favorevolmente per il dipendente, sarà suo interesse chiedere, peraltro entro termini decadenziali, che il procedimento disciplinare venga riaperto, non sussistendo diversamente alcun onere per l’Amministrazione di procedere in tal senso.
Nell’ipotesi invece che sopraggiunga una sentenza irrevocabile di condanna, e il procedimento disciplinare si sia concluso con l’archiviazione, l’UPD riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
Quindi, si riapre il procedimento disciplinare soltanto se c’è stata un’archiviazione ovvero se si debba procedere al licenziamento, non anche per modificare l’entità dell’eventuale sanzione conservativa irrogata (ad esempio 1 mese di sospensione dal servizio e dalla retribuzione invece di 11 giorni).
Nell’ipotesi di procedimento sospeso invece la sua ripresa è onere comunque dell’Amministrazione, sia in ipotesi di assoluzione che di condanna del dipendente.
Nei casi sopra descritti, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, riaperto o ripreso, mediante rinnovo della contestazione dell’addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell’istanza di riapertura (nella sola ipotesi di procedimento non sospeso e di sentenza d’assoluzione). Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell’art. 55-bis del TUPI, con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso.
Ai fini delle determinazioni conclusive, l’ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’art. 653, commi 1 e 1-bis del c.p.p.
L’UPD quindi subirà un vincolo, ex art. 653 c.p.p., in ordine ai fatti storici che l’imputato ha commesso, a prescindere che essi configurino o meno un reato, anche se godrà di autonoma valutazione sugli stessi. In sostanza il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità – fermo, però, il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità e, dunque, della ricostruzione dell’episodio posto a fondamento dell’incolpazione, operato nel giudizio penale.
Indipendentemente dalle determinazioni conclusive adottate dall’Amministrazione per definire il procedimento disciplinare, l’art. 32-quinquies del codice penale prevede ipotesi di estinzione del rapporto di pubblico impiego come sanzione accessoria alla condanna principale.
In tali ipotesi l’Amministrazione non deve far altro che prendere atto di quanto deciso dal Giudice penale, non avendo alcun margine di discrezionalità al riguardo.
La sospensione cautelare dal servizio
«Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente», dispone l’art. 55-ter del TUPI.
Questa è l’ipotesi della sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Tale istituto nel pubblico impiego, a differenza che per la sospensione del procedimento, trova una compiuta disciplina tanto legale che contrattuale.
In particolare, per i Dirigenti scolastici il riferimento è dato dall’art. 30 del CCNL 2016-2018, mentre per il personale docente e ATA dall’art. 15 del CCNL 2016-2018.
Ciò detto, distinguiamo due ipotesi di sospensione cautelare: quella obbligatoria e quella facoltativa.
In entrambe le ipotesi parliamo di un provvedimento cautelare, e non disciplinare, adottato dall’Amministrazione inaudita altera parte che, in base all’organizzazione interna di ciascuna PA, potrebbe essere disposto tanto dall’UPD che dall’Ufficio competente alla gestione delle risorse umane, non esistendo in tal senso una previsione normativa o contrattuale cogente.
Provvedimento che trova la propria ratio nella necessità di tutelare la credibilità dell’amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, che potrebbe rischiare di essere compromesso dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa da cui è colpito un lavoratore attraverso la quale l’amministrazione stessa opera e che è da questi rappresentata.
Al dipendente sospeso sono corrisposti un’indennità (assegno alimentare) pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
Le ipotesi di sospensione obbligatoria sono prevalentemente riconducibili a fattispecie costituenti illeciti penali e il legislatore, al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di avere tempestiva notizia dei processi penali avviati a carico di dipendenti pubblici e del loro esito, ha imposto precisi oneri di comunicazione a carico del Pubblico Ministero (art. 129 disp. att. c.p.p.) e della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 154-ter disp. att. c.p.p.).
La prima ipotesi di sospensione obbligatoria è quella in cui il lavoratore sia colpito da misura restrittiva della libertà personale. In tal caso si viene sospesi d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
Il provvedimento di sospensione è pertanto meramente ricognitivo di un fatto (la restrizione della libertà personale del lavoratore) in cui vi è un’oggettiva impossibilità a fornire la prestazione lavorativa per motivi assolutamente indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione.
La seconda ipotesi ricorre in presenza dei casi previsti dagli artt. 7, comma 1, e 8, comma 1 del D.Lgs. 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità), uno dei decreti adottati su delega della Legge Severino (Legge 190/2012) in materia di anticorruzione.
La terza ipotesi ricorre nei casi previsti dall’art. 4 della Legge 97/2001, che sancisce la sospensione obbligatoria del dipendente di amministrazioni o enti pubblici in caso di condanna, anche non definitiva, per alcuni delitti di particolare gravità contro la PA (ad esempio corruzione o concussione).
Il CCNL 2016-2018 relativo ai Dirigenti scolastici, a differenza che per il personale del comparto, specifica sempre, per ogni ipotesi descritta, che il Dirigente viene sospeso «salvo che l’amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 28, comma 8 (Codice disciplinare), e dell’art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001».
L’art. 28 disciplina le ipotesi di licenziamento, con o senza preavviso, del Dirigente, mentre abbiamo già descritto l’art. 55-ter del TUPI sulla sospensione del procedimento.
Ciò detto, si è portati a ritenere che le descritte specificazioni siano più volte a rimarcare la delicatezza del ruolo del Dirigente scolastico.
Infatti, posto che anche un docente potrebbe essere licenziato anche prima dell’esito del procedimento penale, non è ben chiaro come possa essere alternativamente prevista la sospensione di un Dirigente scolastico colpito da misura restrittiva della libertà personale con il suo licenziamento, all’esito quindi di un procedimento disciplinare che ha dei tempi da rispettare e soprattutto che deve assicurare il rispetto del diritto di difesa del lavoratore.
A meno di non voler dire che lo stesso giorno in cui il Dirigente viene posto in stato di custodia cautelare o agli arresti domiciliari venga licenziato... parrebbe di ardua applicazione la previsione contrattuale, considerato che l’Amministrazione viene a conoscenza del fatto una volta accaduto, non prima.
Facciamo infine riferimento a un’ipotesi di sospensione obbligatoria che però non è legata a un procedimento penale in corso (anche se potrebbe sicuramente essere poi promosso): l’art. 55-quater del TUPI.
La norma è salita alla ribalta della cronaca come quella del “licenziamento dei furbetti del cartellino”.
In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, vi è l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ovvero, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’UPD, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne siano venuti a conoscenza.
Al di fuori delle ipotesi descritte il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale (sospensione facoltativa).
Durata della sospensione dal servizio
Ove l’Amministrazione proceda al licenziamento la sospensione del dipendente conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare.
Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine, essa è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione della sanzione del licenziamento, l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Amministrazione stessa.
In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità della sanzione del licenziamento.
La restitutio in integrum
Tranne il caso in cui il dipendente sospeso venga poi licenziato, e in tal caso, ove la sospensione non abbia avuto soluzione di continuità, il licenziamento decorre dalla data di sospensione, si pone il problema di ripristinare interamente il diritto alla retribuzione del dipendente.
Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso» o «il fatto non costituisce reato» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione (per i Dirigenti) ed escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario (per docenti e ATA).
Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, verrà operato il medesimo conguaglio sopra descritto.
Allontanamento dal servizio
Indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale, l’Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione (art. 14 del CCNL 2016-2018). Per il Dirigente invece la sospensione può essere disposta in concomitanza con la contestazione, e previa puntuale informazione allo stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità (art. 29 del CCNL 2016-2018).
Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
(*le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)