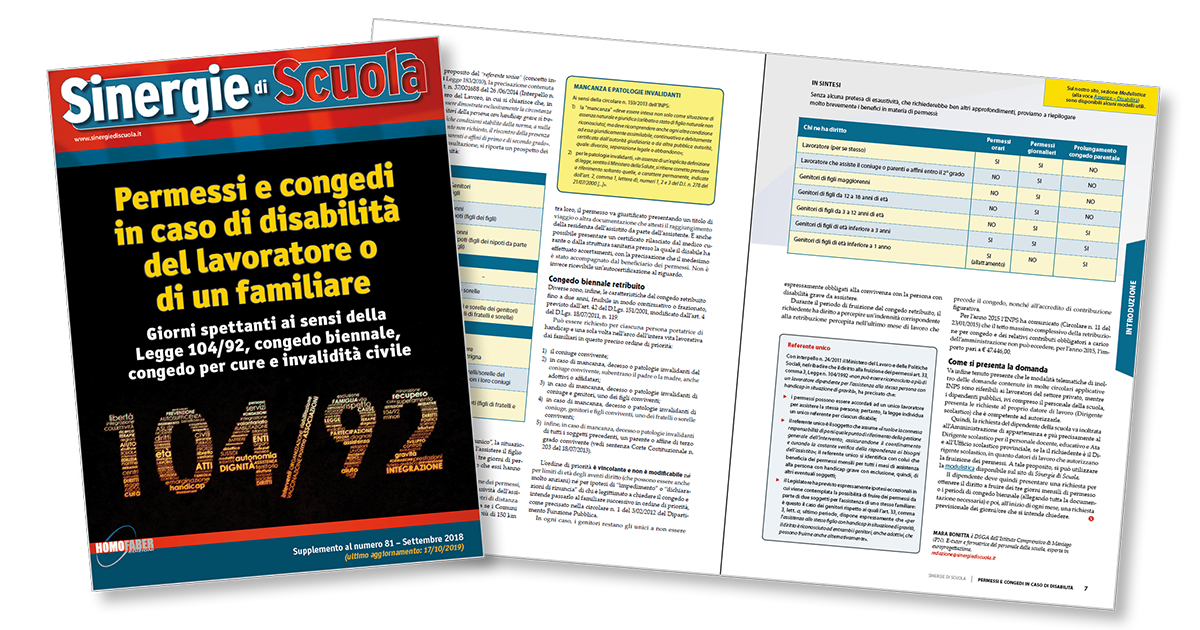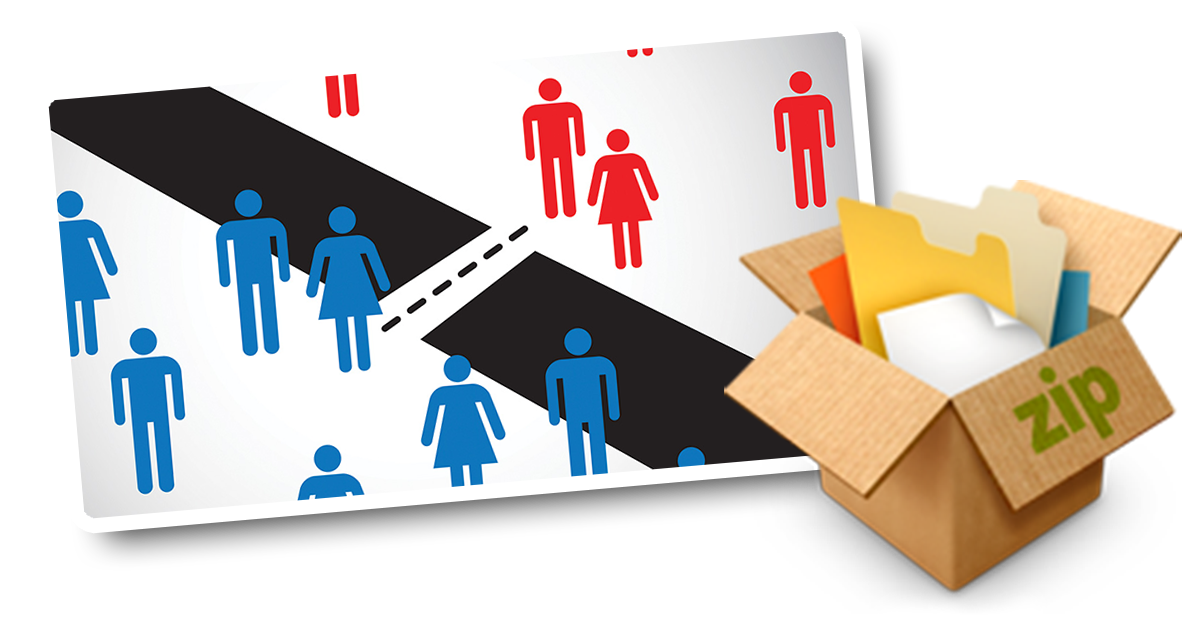Il DSGA di un Istituto scolastico lombardo veniva condannato in I grado dal Tribunale di Pavia (sentenza confermata in appello), per avere formato falsi mandati di pagamento, ovvero corredati da falsi giustificativi, in alcuni casi iniziali in concorso con il Dirigente scolastico, successivamente traendo in inganno il Dirigente scolastico medio tempore subentrato, inducendo così in errore l’istituto di credito presso il quale i mandati erano stati posti all’incasso e appropriandosi del denaro di cui aveva avuto il possesso per ragione del suo ufficio, con rilevante depauperamento dei fondi dell’Istituto scolastico.
I reati per cui veniva condannato sono il peculato e il falso in atto pubblico, in concorso con il primo Dirigente scolastico.
Il DSGA ricorreva alla Corte di Cassazione principalmente eccependo la riqualificazione dei fatti contestati come peculato in termini di truffa, in quanto riteneva che i giudici di merito non avessero chiarito come egli potesse esser ritenuto titolare di una disponibilità giuridica delle somme, di cui si era appropriato solo al termine di una procedura amministrativa complessa, che prevedeva come necessaria, per la liquidazione degli importi dei mandati di pagamento, anche la sottoscrizione del Dirigente dell’istituto scolastico.
Il DSGA dunque, non contestando la propria responsabilità penale, mirava a una riqualificazione dei fatti perché il peculato è un reato sanzionato ben più gravemente della truffa.
Appropriazione indebita, peculato e truffa
Prima di esaminare le motivazioni della Suprema Corte, rassegnate nella sentenza 3920/2022 della sesta sezione penale, procediamo a una sintetica descrizione dei reati in narrativa.
Breve premessa: nel codice penale è previsto il reato di appropriazione indebita, che consiste nella lesione del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, mediante l’abuso di cosa o denaro altrui.
Nell’appropriazione indebita il denaro o la cosa mobile di cui l’agente si appropria, non fanno mai parte ab origine del “patrimonio” del possessore, ma si tratta sempre di denaro o di cose di “proprietà” diretta o indiretta di altri, che pur confluendo per una determinata ragione nel patrimonio dell’agente, non divengono, proprio per il vincolo di destinazione che le caratterizza, di sua proprietà.
Di conseguenza, ove l’agente dia alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede, foss’anche con una condotta omissiva, ovvero a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o il denaro, commette il reato di appropriazione indebita.
Classico esempio di appropriazione indebita è la condotta dell’amministratore condominiale che, riscosse le rate condominiali, ometta poi di effettuare i dovuti pagamenti cui è tenuto il condominio.
Ciò premesso, il peculato è un delitto che si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro o di altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.
Nel diritto romano per peculato si intendeva inizialmente il furto o la sottrazione di bestiame per poi divenire, e così nei secoli a venire, il reato che identificava l’appropriazione illecita di denaro pubblico.
Il peculato è un c.d. “reato proprio”, in quanto può essere commesso esclusivamente da chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Per pubblico ufficiale deve intendersi sia colui che tramite la sua attività concorre a formare quella della PA, sia colui che è chiamato a svolgere attività aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali (il DSGA e il Dirigente scolastico sono chiaramente dei pubblici ufficiali).
Il peculato è un reato che, nel tutelare il patrimonio pubblico, o altrui ma detenuto dalla PA, vuole garantire il buon andamento, l’imparzialità e l’efficienza dell’attività della pubblica amministrazione, diversamente lesa dalle condotte illecite perpetrate dai suoi stessi organi.
Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione dell’oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell’agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede il bene altrui (a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione) per questo il peculato è anche un c.d. “reato istantaneo”.
Passando al reato di truffa, questo è un delitto contro il patrimonio procedibile a querela di parte tranne che nelle ipotesi di truffa aggravata (ad es. nel caso di truffa ai danni dello Stato). Non esiste dunque un reato proprio di “truffa ai danni dello Stato”, ma questa è un’aggravante del generico reato di truffa.
Chi commette il reato di truffa mette in atto artifizi o raggiri con i quali la vittima del reato viene indotta in errore.
Si può definire l’artificio come lo strumento attraverso cui si fa apparire per vera una situazione che in realtà non è tale o tramite cui si dissimula una circostanza in realtà inesistente.
Il raggiro invece consiste nell’affermazione di una falsa verità in modo tale da convincere un’altra persona che un determinato fatto sia vero, orientandone quindi il comportamento in maniera fuorviante.
Quest’ultimo profilo rappresenta la c.d. “induzione in errore” di un soggetto terzo affinché il truffatore possa conseguire un ingiusto profitto patrimoniale.
Su tutti, come esempio di truffa, rammentiamo il famoso e notorio episodio cinematografico del Cavalier Antonio Trevi (Totò) e del rag. Girolamo Scamorza (Nino Taranto) che, con artifizi e raggiri, offrono in vendita all’arricchito “paisà” italo-americano Decio Cavallo (Ugo D’Alessio) la fontana di Trevi in Roma (opera dello svizzero Bernini, così chiamato perché di Berna e di piccola statura, dice Totò), facendo credere al malcapitato che questa fosse di proprietà del “presunto ereditiero” Cavalier Trevi.
La decisione della Cassazione
L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo il peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la truffa quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.
Poiché il peculato è un reato a carattere plurioffensivo, inteso, da un lato, alla tutela dell’interesse statale della “funzionalità operativa” della PA, sotto i molteplici profili della legalità, efficienza e imparzialità, e, dall’altro, alla protezione dei beni patrimoniali che sono affidati ai pubblici funzionari, ne deriva che l’eventuale mancanza o particolare modestia del danno patrimoniale, conseguente all’appropriazione, non esclude la sussistenza del reato, considerato che rimane pur sempre leso dalla condotta dell’agente l’altro interesse, diverso da quello patrimoniale ma ugualmente protetto dalla norma, e cioè il buon andamento della pubblica amministrazione.
Poiché della gestione del denaro dell’Istituto scolastico si occupava il DSGA, che emetteva e firmava i mandati di pagamento poi controfirmati dai Dirigenti scolastici succedutisi nel tempo, è irrilevante che questi ultimi, laddove non correi, non avessero esercitato un reale controllo sul contenuto dell’atto dispositivo.
Né a differenti conclusioni si potrebbe pervenire valorizzando la circostanza che il mandato di pagamento non sarebbe stato pagato se non in presenza delle firme sia del DSGA che del Dirigente scolastico: i giudici di merito hanno accertato come il controllo contabile fosse nelle mani del DSGA e come fosse stato questi a predisporre, in via esclusiva, i falsi mandati di pagamento.
Pertanto, è stata accertata la commissione del delitto di peculato da parte del DSGA, in relazione all’illecita distrazione di denaro pubblico, anche se il relativo possesso, per effetto delle norme interne dell’ente pubblico che prevedono “procedure complesse” e il concorso di più organi ai fini dell’adozione dell’atto dispositivo, facesse capo congiuntamente a più pubblici ufficiali.
In tal caso, pur se il Dirigente scolastico (il secondo chiaramente, non il prima correo) aveva partecipato con la sua sottoscrizione all’emissione dei falsi mandati di pagamento, questi è stato ritenuto esente da responsabilità penale per essere stato indotto in errore dal DSGA che si era occupato della fase istruttoria procedimentale, sottoponendo “alla firma” i titoli falsi.
Ulteriori spunti
La sentenza in commento offre spunti di riflessione, oltre che per i diretti profili penali, anche per almeno due diversi temi:
- Esclusa la responsabilità penale, il Dirigente scolastico, in un caso come quello descritto, è esente da altre forme di responsabilità?
- Qual è il ruolo del DSGA negli Istituti scolastici?
Con un prossimo contributo si fornirà risposta ai quesiti.
(le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)