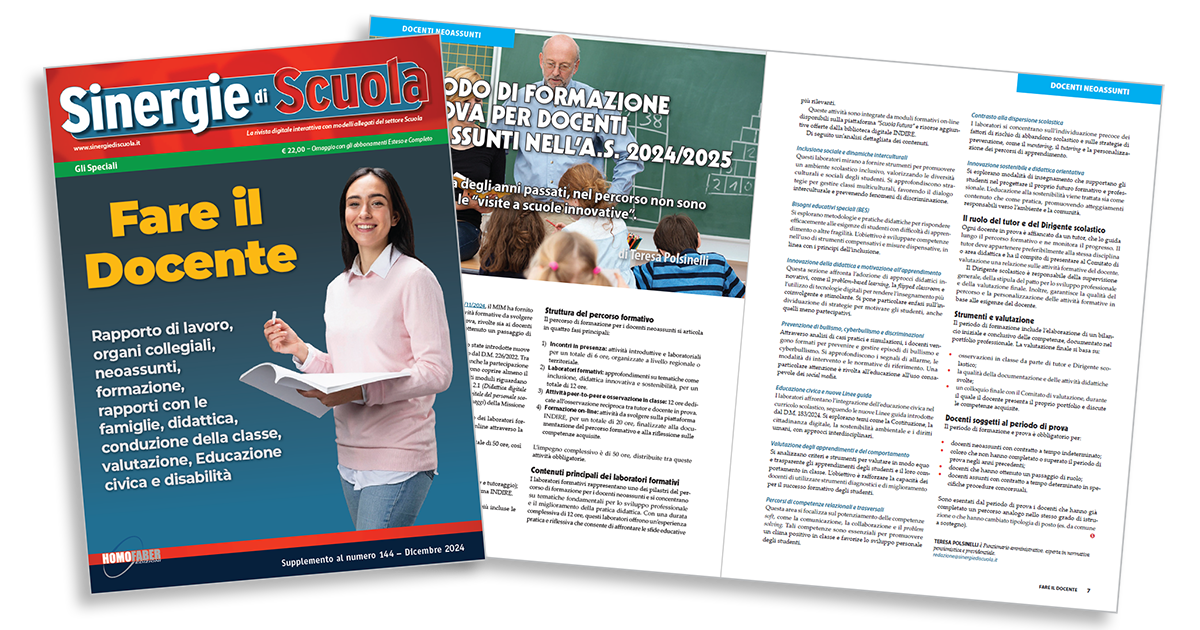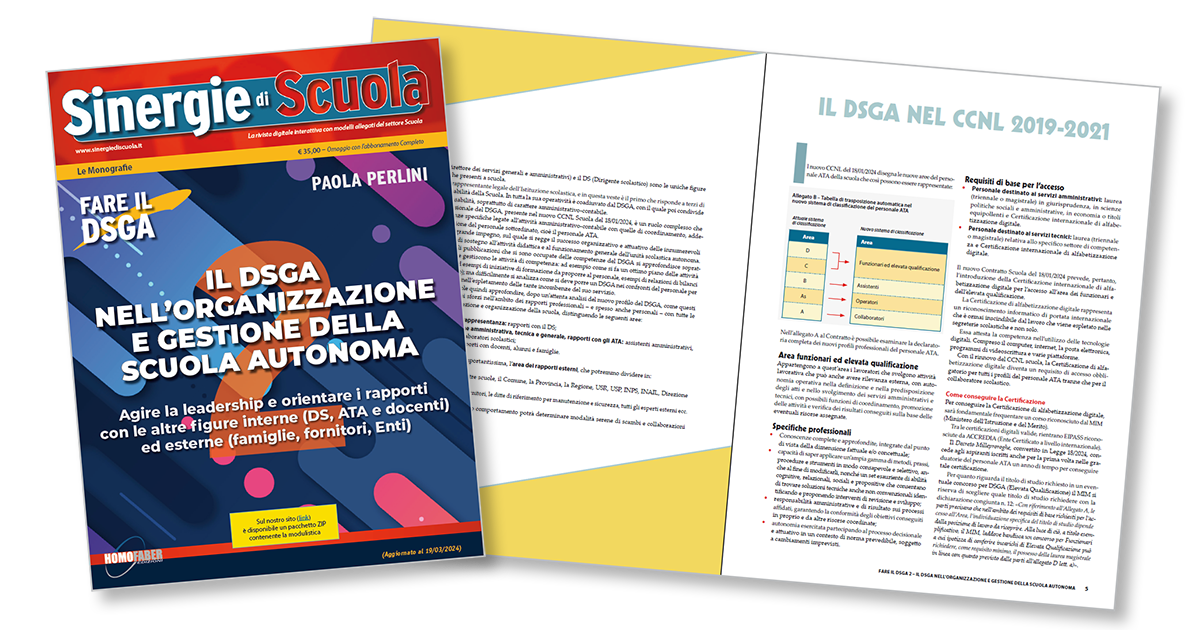La Corte dei Conti si è pronunciata sovente su casi di omessa vigilanza, ragion per cui abbiamo a disposizione un folto numero di sentenze che hanno visto il giudice contabile esprimersi sia pro che contro docenti coinvolti nelle vicende che hanno portato al giudizio.
Prima di entrare nel vivo della ricostruzione del pensiero dei giudici sulla materia, vale la pena riepilogare brevemente i termini e la sequenza delle attività e delle operazioni che portano il docente davanti al giudice contabile.
Responsabilità per colpa grave
In tema di responsabilità civile derivante da omessa vigilanza, la legge limita ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità del personale scolastico per danni, arrecati direttamente all’Amministrazione, in connessione a comportamenti degli alunni sotto vigilanza.
Questa limitazione vale per il docente, ma non per l’Amministrazione che, al contrario, risponde indipendentemente dal grado di colpa del dipendente pubblico, autore del danno.
Tale regime è introdotto dalla Legge 312/1980 (art. 61), che anticipa la riforma del 1994 relativa al livello di colpa del dipendente pubblico che, all’epoca, rispondeva anche per colpa lieve.
L’art. 61 è esteso ai casi di responsabilità del personale scolastico verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza.
La Corte Costituzionale, con sentenza 64 del 24/02/1992, ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 della Legge 312/1980 per contrasto con l’art. 28 della Costituzione, benché detta limitazione possa esser vista come un vero e proprio esonero degli insegnanti dalla responsabilità verso terzi per i danni da culpa in vigilando.
A questa casistica va aggiunto il fenomeno dell’autolesione, che la dottrina e la giurisprudenza hanno assimilato a danno contrattuale, lasciando all’Amministrazione, anche in questo caso, l’onere della prova a discarico, cioè l’onere di dimostrare che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere.
Quindi, la disciplina dell’art. 61, stabilendo che il docente può rispondere solo per il danno subito dall’Amministrazione (danno indiretto) e solo nell’ipotesi di condotta gravemente colposa o dolosa, rende di fatto processualmente non applicabile la presunzione di cui all’art. 2048, comma 2 del codice civile che prevede, di contro, la responsabilità dei docenti per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
In questi casi, infatti, l’Amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Ad essere chiamato in causa è dunque il Ministero, che deve dimostrare che l’evento dannoso era assolutamente imprevedibile e repentino e dare, se possibile, prova di non aver potuto impedire il fatto. In questa fase il docente può essere coinvolto solo in qualità di testimone.
Questa evenienza può essere utile al docente, il quale, nel caso di azione di rivalsa, avrà consegnato al giudice contabile elementi valutativi che attengono concretamente al comportamento da lui tenuto durante l’accadimento lesivo.
Il nuovo giudizio davanti alla Corte dei conti
Una volta emanata dal Tribunale ordinario la sentenza di condanna pecuniaria dell’Amministrazione, eseguita la sentenza con il pagamento in denaro, insorge in capo alla stessa l’obbligo di denuncia alla Procura generale della Corte dei conti per la verifica della sussistenza dei presupposti per l’azione di rivalsa nei confronti del docente.
La Corte dei conti instaura un nuovo giudizio per verificare la responsabilità dell’insegnante nell’accadimento lesivo. Si tratta di un giudizio diverso da quello già svolto davanti al giudice civile, perché in questo caso non vi è la presunzione di colpa come nel giudizio civile, ma vanno valutate ex novo tutte le circostanze.
Per effetto di questa separatezza di giudizi, la Corte dei conti può esercitare il cosiddetto “potere riduttivo”, condannando il docente al pagamento di una somma all’Amministrazione minore rispetto a quanto risarcito al danneggiato. In questa fase la responsabilità del docente non è qualificabile come responsabilità civile, ma come responsabilità amministrativa o patrimoniale.
Culpa in vigilando: cosa dicono le sentenze
Una serie di sentenze riguarda gli infortuni occorsi agli studenti durante le lezioni di Scienze motorie. Le variabili da considerare sono afferenti alla naturale pericolosità delle attività, allo stato dei luoghi, all’attenzione specifica richiesta al docente. I giudici riconoscono la responsabilità per colpa grave del docente legata principalmente al ruolo dello stesso, unico soggetto – in quanto presente – che avrebbe potuto evitare l’evento dannoso. Altri casi di riconoscimento della responsabilità amministrativa del docente si fondano sempre sulla verifica dell’elemento della volontà, la colpa grave, riscontrabile in comportamenti concreti e sulla base della valutazione del caso specifico, delle circostanze e anche del comportamento degli stessi alunni.
In generale, quando il giudice contabile valuta la colpevolezza grave del docente, non si ferma all’acquisizione dei documenti prodotti nel rito civile (dichiarazioni, perizie, rilievi) né alla sentenza del giudice civile, ma va alla ricerca della prova della negligenza nello svolgimento delle proprie funzioni, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l’osservanza della necessaria diligenza. Ad essere posta sotto la lente di ingrandimento è dunque la condotta del docente, che si vede costretto a ricostruire a distanza di anni eventi i cui dettagli iniziano a perdersi nel tempo.
In base alla espressa limitazione della responsabilità amministrativa ai casi di dolo o colpa grave ovvero all’abbassamento della soglia d’imputabilità (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 313/1997), la giurisprudenza afferma in generale: è necessario dimostrare l’esistenza della specifica colpa grave di ciascun convenuto attraverso la rigorosa analisi delle singole condotte contestate (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 1352/2010); non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa grave ma soltanto quello contraddistinto da precisi elementi qualificanti in tal senso, elementi che vanno accertati caso per caso in relazione alle modalità del fatto e all’atteggiamento soggettivo dell’autore del danno.
Per comprendere le tendenze giurisprudenziali è opportuno ricordare l’esclusione del principio di responsabilità oggettiva relativamente alla valutazione del grado di colpa del personale scolastico nell’esercizio dell’attività di vigilanza degli alunni. Inoltre, bisogna rammentare che nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti il dipendente è convenuto non per il danno arrecato a terzi, bensì per quello cagionato alla Pubblica Amministrazione a causa di un comportamento violativo degli obblighi connessi al rapporto di servizio.
In questo le differenze rispetto al procedimento civile sono notevoli. Infatti il giudice civile, nell’accertare la responsabilità dell’Amministrazione per fatto del proprio dipendente, si limita a verificare una attività colposa di questi, senza indagare il grado di colpa; nel giudizio contabile, viceversa, la verifica della colpa grave è essenziale per affermare la responsabilità del dipendente. Il risarcimento del danno al terzo operato dall’Amministrazione costituisce quindi mero presupposto di fatto per l’esercizio dell’azione di responsabilità, e il giudice contabile può autonomamente valutare i fatti alla luce dell’esito del giudizio civile, utilizzando gli elementi e i mezzi di prova acquisiti in quel giudizio come indizi, nel contesto del quadro probatorio offerto dal pubblico ministero contabile.
In sostanza, il docente che si trova coinvolto in un procedimento davanti alla Corte dei conti dovrà affrontare un iter lungo e stressante, non solo da un punto di vista psicologico ma anche da un punto di vista patrimoniale, dal momento che, a prescindere dall’esito del giudizio, dovrà farsi carico delle spese giudiziarie che in questi casi possono rivelarsi particolarmente onerose. Inoltre, ritrovarsi coinvolti in un processo relativo a fatti accaduti anni prima, aumenta notevolmente anche il carico di stress emotivo legato alla difficoltà di ricostruire eventi di cui spesso non si ha più un ricordo così netto e nitido.