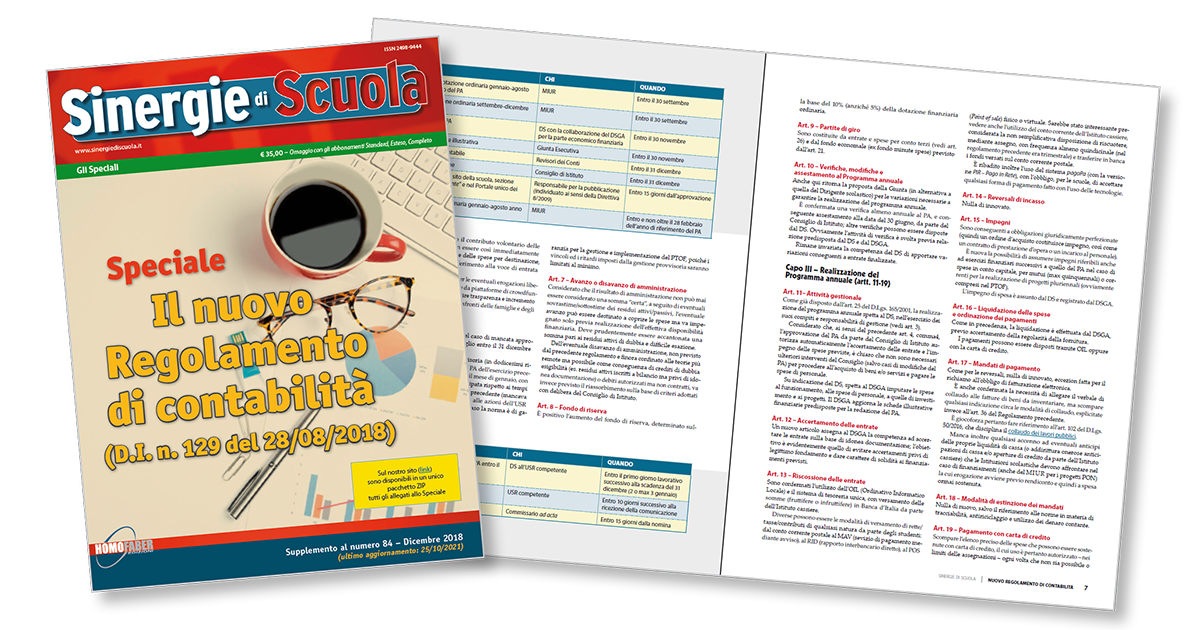Recentemente (il 9 novembre 2021) è apparsa sui social-media la notizia di una sentenza del Tribunale di Firenze che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e l’assicurazione della scuola a risarcire un minore studente e la famiglia per un totale di 95 mila euro.
Il risarcimento è stato riconosciuto per gli atti di bullismo cui è stato sottoposto per anni il giovane, peraltro con difficoltà deambulatorie, tra i banchi di una scuola elementare. Ha dovuto subire sia aggressioni fisiche (pugni nello stomaco, calci in faccia, una mano fratturata) che morali (gravi insulti, a ricreazione o subito dopo la campanella). Azioni così insopportabili da fargli pensare di togliersi la vita.
Su quelle aggressioni, atti di bullismo dunque, l’Istituto avrebbe dovuto prendere provvedimenti, ma purtroppo...
Come commentato dal legale del minore, la condanna è importante perché per la prima volta il tribunale riconosce la ripetitività delle condotte: per questo si parla di bullismo, non di semplici lesioni a scuola.
Il Ministero sembra abbia deciso di non appellare la sentenza e credo sia un gesto nobile, ancorché dovuto.
La notizia ha avuto ampia eco mediatica; con il presente contributo esamineremo i temi rilevanti che sono alla base della vicenda.
Il bullismo, fenomeno di intolleranza
Senza alcuna velleità di poter competere nelle professioni scientifiche, possiamo in buona sintesi dire che il bullismo si compone di più azioni aggressive, fisiche e/o morali, o comportamenti di esclusione sociale reiterati, in modo intenzionale e sistematico, da uno o più persone ai danni di una vittima, che spesso ne è a tal punto succube da chiudersi in sé stessa per paura di più gravi vessazioni.
Il bullismo si caratterizza per l’intolleranza verso chi è “diverso” per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari.
Il bullismo è, si passi il pensiero personale, quanto di più vigliacco e crudele possa esser fatto contro chi, per cause diverse, è un soggetto fragile.
Non esiste nell’ordinamento italiano un’esplicita definizione normativa di “bullismo”, è però in esame al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1690, già approvato dalla Camera dei Deputati, ad oggetto “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo”.
Esiste invece una disciplina sul fenomeno del cyberbullismo, introdotta con la Legge 71/2017, che lo definisce come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Facciamo dei distinguo: se nel bullismo sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell’Istituto, nel cyberbullismo può essere coinvolto chiunque da tutto il mondo; e ancora, se le azioni di bullismo avvengono durante l’orario scolastico o nel tragitto casa-scuola/scuola-casa, il cyberbullismo può avvenire 24 ore su 24 sul web.
Le Linee guida del M.I.
Per quanto riguarda la scuola, il Ministero ha da ultimo adottato la circolare prot. 482 del 18/02/2021 ad oggetto: “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado” (aggiornamento delle precedenti linee guida del 2017, ndr).
Per il Ministero «è prioritaria la tutela assoluta della potenziale vittima, in termini di attenzione agli indicatori, prevenzione delle situazioni di vittimizzazione (indicatori di segnale di sofferenza e/o attacco dell’aggressore) e supporto e riservatezza assicurati alla vittima da parte della rete di adulti».
Prevenzione e intervento dunque!
Come evidenziato dal legale del minore bullizzato, affinché si parli di bullismo è fondamentale che vi sia una reiterazione delle condotte; questo aspetto diviene rilevante per la responsabilità di chi dovrebbe educare il minore e vigilare sui suoi comportamenti.
Questo è il motivo per cui il Ministero dell’Istruzione è stato condannato a un risarcimento importante, in quanto non è tollerabile – e dunque estremamente grave! – che un minore subisca vessazioni per anni.
Responsabilità degli atti di bullismo
Prima di esaminare in dettaglio la responsabilità della scuola al verificarsi di fenomeni di bullismo è bene rammentare che sovente questo può integrare diverse fattispecie di reato.
Accanto alle norme poste a protezione dell’incolumità della persona vi sono quelle relative alla tutela dell’onore, della libertà e anche del patrimonio della persona offesa.
Ad esempio, con la sentenza 28623/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che gli atti di bullismo posti in essere nei confronti della vittima integrano pienamente il reato di atti persecutori, previsto e punito dall’art. 612-bis del Codice Penale.
È opportuno ricordare che la responsabilità penale è personale e i minori di 14 anni non sono perseguibili penalmente (anche se le loro condotte possono sicuramente esser seguite dai servizi sociali per ogni azione ritenuta idonea dal Giudice dei minori).
La responsabilità della scuola è dunque una responsabilità di natura civile.
L’art. 2048 del codice civile sancisce la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte per «il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori, delle persone soggette alla tutela, che abitino con essi, [...] [e] degli allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
Tale norma non prevede alcuna differenziazione fra i minori a seconda della loro età, sicché il regime di responsabilità che deriva dall’illecito civile di un sedicenne è uguale a quello che consegue dal medesimo fatto di un undicenne, pur se la giurisprudenza tende a evidenziare come l’età del minore attenui o aggravi a seconda dei casi l’obbligo di vigilanza di cui si dirà ora.
Si è chiamati a rispondere del fatto illecito quindi tanto per una culpa in educando (sancita dall’art. 147 c.c.) che in vigilando, che rappresenta l’obbligo di vigilare sulla condotta del minore in modo da prevenire la commissione dell’illecito.
I soggetti indicati dall’art. 2048 c.c. come responsabili delle condotte del minore, assolti diligentemente i propri obblighi educativi e di vigilanza, sono esenti da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Ciò premesso, il titolo della responsabilità del Ministero, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola, è di natura contrattuale.
È ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui l’ammissione del minore a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’Istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dello studente nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche durante il pre/post scuola o durante le gite scolastiche quindi) e, pertanto, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: dalle circostanze ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose ed a persone.
Si tratta di un’ipotesi di responsabilità presuntiva e oggettiva, e di tale responsabilità speciale (trattandosi di regola che fa eccezione alla regola generale del divieto del neminem laedere posta all’art. 2043 c.c.) ex art. 2048, comma 3 c.c., si libera soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto (c.d. responsabilità aggravata).
Questo assunto è fondamentale perché ne consegue l’applicabilità del regime probatorio sancito dall’art. 1218 c.c.
Se quindi il minore (rectius i suoi genitori) deve soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico, sul Ministero incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante o al personale ATA addetto alla sorveglianza (ex multis Corte Cass. n. 3680/2011 e n. 13457/2013).
Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. III n. 22541/2019) riconosce che spetta alle istituzioni, ed in particolare alla scuola, intervenire per arginare il fenomeno del bullismo e per sostenere le giovani vittime, senza addossare a queste ultime e alle loro famiglie l’intera responsabilità per i danni eventualmente cagionati da reazioni che possano essere dettate dall’esasperazione.
(*le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)